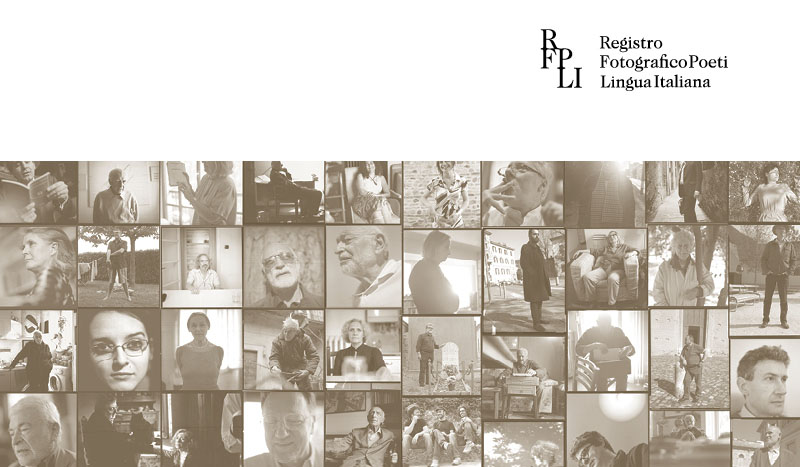NICOLA GARDINI, IL LIBRO È QUELLA COSA – GARZANTI, MILANO 2020
Mi sono imbattuta nelle pagine de Il libro è quella cosa con tre anni di ritardo, e mi dispiace perché si tratta di un volumetto prezioso, da leggere e da regalare: ai bibliofili, anzi meglio, ai bibliomani. A tutte le persone che amano spiare nelle vetrine delle librerie, cercare le novità editoriali sui giornali, spulciare le recensioni, ascoltare le ormai rare trasmissioni radiofoniche e televisive che suggeriscono imperdibili tesori cartacei.
Nicola Gardini, nato nel 1965 in Molise ma cresciuto a Milano, professore di Letteratura Italiana all’Università di Oxford, autore di decine di volumi (poesia, narrativa, saggistica), ricercato traduttore dall’inglese e dal latino, appassionato sostenitore dell’importanza di studiare le lingue antiche, presidente della casa editrice Salani, e infine pittore, nutre un rapporto d’amore esclusivo, quasi ossessivo, forse addirittura feticistico per i libri. Si dichiara affascinato non solo dal loro contenuto, ma anche dalla loro forma esteriore: copertina, dorso, rilegatura, pagine, colore e odore. “Un libro è una cosa da avere; cosa con cui si abita e si viaggia, da cui magari alla fine ci toccherà separarci, ma che occorre far di tutto per conservare e tenere vicino”.
Gardini ammette di essere un acquirente compulsivo, attratto dai titoli, dalle immagini, e spinto al possesso dell’oggetto anche quando non gli è necessario. Confessa la sua dipendenza, quasi fosse una droga: “Quanti libri ho…? Io mi domando: quanti libri non ho?”. Senza nemmeno conoscere autori, argomenti e trame, compra e colleziona volumi, li accumula, li impila, se ne circonda ovunque, pur sapendo che mai arriverà a leggerli tutti. Diventano un alibi, un patto, una lusinga, un rammarico. “Il libro che si deve ancora leggere ci sta davanti con una promessa e con un rimprovero; e poi, se non ci decidiamo mai a leggerlo, con un rimpianto”. Perché ammassarli, allora, sapendo che non si arriverà nemmeno ad aprirli? “Che cosa ci fanno, infine, tutti quei libri sugli scaffali? Ci danno fiducia”. Viene da chiedersi cosa provochi la felicità di stringere tra le mani un volume appena acquistato, e perché tanta nostalgia per uno perduto, uno sulle cui pagine ci si è addormentati da bambini, un altro studiato con devozione al liceo. Gardini dà a sé stesso una spiegazione filosofica, ben sapendo quanto sia relativa: “un libro è l’unica cosa che non minacci di toglierci nulla”. Anzi, offre parole e insegnamenti, e accoglie le nostre annotazioni, date, sottolineature, ciò che verghiamo sulle sue pagine a matita, a penna, con l’evidenziatore, per farlo più decisamente nostro. Conserva all’interno bigliettini, cartoline, ricevute, fotografie dimenticate da anni: è un amico fedele, non butta via niente, ha una memoria di ferro e ricorda l’età in cui l’abbiamo letto. È uno specchio di noi, un diario implacabile.
Gardini racconta le relazioni che ha intrecciato con altre persone grazie ai libri: con la mamma che li nascondeva nell’armadio perché non si sciupassero, con il padre in pensione che glieli catalogava rimproverandogli lo spreco di denaro, con l’ex-insegnante malato terminale che svendeva la sua biblioteca per lasciare più soldi ai figli, con la cugina o i compagni di scuola che glieli prestavano. Lo scambio e il commento reciproco di letture crea una rete di rapporti che mette in comunicazione con la società, sopravvivendo anche alla messaggistica di internet e agli e-book, su cui il giudizio dell’autore è severo: “La comunicazione elettronica è rapida, distratta, imprecisa… estromette del tutto il ragionamento, la riflessione, il ripensamento, il piacere dell’immaginazione, la proiezione nell’altro, l’attesa, la considerazione di più possibilità, la sospensione fantastica”. Leggere è invece un’arte paziente, che si impara stando con le parole, innamorandosene, lasciandosi penetrare da esse, smarrendosi in loro, viaggiando con loro.
Una intensa dichiarazione d’amore espressa in paragrafi stringati, aforismi, citazioni, che Nicola Gardini rivolge a “quella cosa” che si chiama libro, in un’epoca come la nostra abituata a leggere poco e male, con superficialità e fretta, ignara della ricchezza a cui sta rinunciando.
© Riproduzione riservata «Gli Stati Generali», 22 gennaio 2024