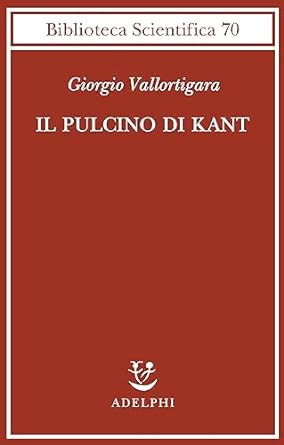MAURIZIO DIANESE, GIANFRANCO BETTIN – LA TIGRE E I GELIDI MOSTRI
FELTRINELLI, MILANO
“Strategia della tensione” fu la definizione coniata dal quotidiano inglese The Guardian subito dopo la strage di Piazza Fontana, per indicare il processo destabilizzante in atto in Italia negli anni tra il ’60 e l’80, anni contraddistinti da lotte sociali particolarmente combattive, e contrastate con forza dai governi dell’epoca, appoggiati da apparati chiave della nazione (magistratura, forze armate, forze dell’ordine, intelligence). Lo scorso 9 maggio, nella Giornata della Memoria delle vittime del terrorismo, il Presidente Sergio Mattarella ha affermato che le stragi di quel periodo sono state effettuate “con la complicità di uomini da cui lo Stato e i cittadini avrebbero dovuto ricevere difesa”, attraverso “gravi deviazioni compiute da elementi dello Stato, e per le quali avvertiamo ancora l’esigenza, pressante, di conoscere la piena verità”.
Il 20 giugno del 1980, pochi giorni prima di essere assassinato dai Nar a Roma mentre indagava sull’eversione nera, il sostituto procuratore Mario Amato aveva dichiarato di stare per giungere “alla visione di una verità d’insieme, coinvolgente responsabilità ben più gravi di quelle stesse degli esecutori materiali degli attacchi criminali”. Il volume di Maurizio Dianese e Gianfranco Bettin, La tigre e i gelidi mostri, appena pubblicato da Feltrinelli, si propone di mettere in luce quale fosse la “verità d’insieme”, l’oscuro ordito alla base di tale disegno sovvertitore, presentando materiali originali, nomi inediti di stragisti, e riflessioni sulle sentenze giuridiche emesse in interminabili, macchinosi e discutibili processi.
Il titolo scelto dagli autori per il loro libro esige una spiegazione. Nietzsche nello Zarathustra chiamava lo Stato “il più gelido dei mostri”, nella sua funzione autoritaria e repressiva di contenimento del dissenso. “La tigre” è una metafora riferita al grande cambiamento democratico che ha investito l’Italia nei decenni presi in considerazione, in cui una profonda trasformazione socioeconomica e culturale incoraggiava l’affermazione di atteggiamenti, ideologie e sensibilità radicalmente innovative e capaci di autodeterminazione, indipendenti dai modelli tradizionali. Tale evoluzione era stata prodotta da diverse cause: lo sviluppo industriale, la mobilità interna, la scolarizzazione di massa, i nuovi media, la crescita del reddito e dei consumi, i ruoli inediti interpretati dalle donne e dagli studenti, il diffondersi di teorie e prassi filosofiche e scientifiche come la psicanalisi e il femminismo. La minaccia rappresentata da questo movimento rinnovatore (the silent revolution) spaventava l’establishment politico, culturale, economico e industriale: secondo un detto sapienziale dell’Estremo Oriente, bisogna cavalcare la tigre per domarla, dirigerla e possibilmente renderla innocua.
Un piano di restaurazione era già in atto dalla fine del secondo conflitto mondiale, durante la Guerra fredda (1947-1991), programmato da settori cruciali dell’amministrazione degli Stati Uniti, presenti sul territorio italiano con basi militari proprie e della Nato, appoggiati da servizi e strutture militari e da gangli di potere occulti (come la Loggia massonica P2), da diversi settori dell’economia e dell’impresa, da aree della criminalità organizzata, di gruppi neofascisti (soprattutto Ordine nuovo, Avanguardia nazionale, Fronte nazionale e Nuclei armati rivoluzionari) e di agenzie terroristiche internazionali come l’Aginter Presse. Tali settori pianificarono di usare la tensione e i traumi provocati dagli attentati per condizionare in senso moderato e “centrista” una situazione che avrebbe potuto sfociare verso la proclamazione dello stato d’emergenza, con la sospensione della Costituzione o l’attuazione di un colpo di Stato, come in Grecia nel 1967 e in Cile nel 1973, mentre erano ancora in piedi le storiche dittature franchista in Spagna e salazariana in Portogallo, e si moltiplicavano i regimi militari in America Latina e altrove.
Carlo Feltrinelli afferma nell’introduzione al libro: “In Italia hanno agito, con il supporto di settori cruciali dello Stato, militanti e organizzazioni neofasciste che non solo praticavano azioni criminali e violente, ma concepivano la strage indiscriminata come forma di lotta politica e di condizionamento emotivo del paese”.
Infatti, agivano ancora in Italia molte figure compromesse col regime fascista e con la Repubblica di Salò, con l’intento di “destabilizzare l’ordine pubblico per stabilizzare l’ordine politico”. II I maggio 1947 in Sicilia l’eccidio politico-mafioso di Portella della Ginestra, attuato dalla banda di Salvatore Giuliano al servizio dei proprietari terrieri, aveva provocato 11 morti e 47 feriti.
Su questo sfondo complesso e ambiguo si muovevano gli attori delle vicende raccontate da Dianese e Bettin, in una narrazione che pur utilizzando gli strumenti dell’analisi storica e dell’inchiesta sul campo, presenta anche la struttura e la vivacità del romanzo d’azione.
I tre episodi drammatici dello stragismo in Italia (Piazza Fontana a Milano nel 1969, Piazza della Loggia a Brescia nel 1974, Stazione di Bologna nel 1980) vengono riscostruiti puntualmente indagando nel retroterra ideologico degli attentatori, nell’ideazione e nella programmazione dei crimini terroristici, nell’individuazione di protagonisti e comprimari, nel rifornimento di armi ed esplosivi, attraverso un minuzioso resoconto di date, orari, incontri clandestini, testimonianze, registrazioni di verbali e interrogatori, e lo studio circostanziato di prove processuali e finanziarie , oltre a una “montagna di documenti, contributi storiografici, analisi storico-politiche”. Soprattutto ci si sofferma sullo scandaloso susseguirsi di depistaggi, insabbiamenti, occultamento di prove, suicidi e trasferimenti di appartenenti alle forze dell’ordine, citando nomi e ruoli dei responsabili e delle vittime delle falsificazioni e delle censure che hanno accompagnato vent’anni di attività sovversiva in Italia. Gran parte di questa documentazione è stata resa nota nella serie infinita di processi, inchieste giornalistiche, indagini della magistratura, cui si sono accompagnate spesso congetture velleitarie e interpretazioni pregiudiziali, nell’immaginario collettivo stimolato da un’incontrollata emotività e da suggestioni artistiche.
Il merito di questo nuovo volume di Dianese e Bettin, che già nel 1999 e nel 2019 avevano firmato insieme due pubblicazioni su Piazza Fontana, è quello di aver individuato e pubblicato i nomi degli esecutori materiali degli eccidi di Milano e Brescia, cresciuti fisicamente e ideologicamente negli ambienti fascisti veneti e lombardi. Di Verona, città con comprovate tradizioni reazionarie sia in campo politico sia in quello religioso, era Claudio Bizzari, militante di Ordine Nuovo, figlio di un funzionario di banca ex-repubblichino. Più volte indagato e denunciato per atti dinamitardi e diffusione di stampa sovversiva, con una formazione militare tra i paracadutisti del corpo degli alpini,
Bizzari avrebbe posizionato la bomba nella Banca Nazionale dell’Agricoltura, che provocò 17 morti e 88 feriti.
A Brescia invece l’indagine ruota intorno alla figura del ventunenne Silvio Ferrari, attivo militante neofascista nella sua città, saltato in aria dieci giorni prima dell’attentato del 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia, mentre trasportava di notte sullo scooter un ordigno ad accensione programmata composto da un chilo di tritolo e nitrato di ammonio, destinato a esplodere contro l’agenzia pubblicitaria del “Corriere della Sera”. Se in un primo momento si era pensato a un incidente provocato dall’imperizia del ragazzo, nel corso degli anni si fece strada l’ipotesi (suffragata da numerose testimonianze e fotografie, in particolare della sua fidanzata Ombretta Giacomazzi) che la sua morte fosse stata stabilita dai suoi stessi camerati di Ordine nuovo, insieme a due ufficiali dell’esercito italiano con delicati incarichi istituzionali e a due ufficiali americani, come punizione per aver visto e parlato troppo. Il volume di Dianese e Bettin riporta nomi e cognomi di tutte le persone coinvolte sia nelle riunioni complottiste sia nelle indagini, spesso lacunose o fuorvianti. Quegli anni foschi restituiscono figure di ragazzi “che non si sottraevano all’idea di commettere una strage per odio politico e fanatismo ideologico e per venale interesse, di soldi e ruoli da acquisire nella struttura di potere occulta che li aveva ingaggiati. Ancor più… sbalzano di fronte a noi l’infedeltà alla Repubblica e alle sue leggi, a cominciare dalla Costituzione, di uomini dello Stato disposti a tutto, anch’essi per tramare e interpretare il potere come arbitrio, per preparare una piena e palese assunzione di dominio”.
Dopo la morte di Silvio Ferrari, il 28 maggio in Piazza della Loggia venne fatta deflagrare una bomba durante una manifestazione sindacale indetta “contro l’aggressività criminale del neofascismo”: gli otto morti e un centinaio di feriti attendono ancora giustizia, dopo sei processi, di cui uno tuttora in corso.
Il clima politico italiano era all’epoca incandescente, non solo per l’avanzata elettorale del Movimento Sociale a cui si contrapponeva l’esito positivo del referendum sul divorzio, ma anche per l’intensificarsi di attentati, a cui l’Italia democratica tentava di rispondere sia in Parlamento (il Presidente della DC Arnaldo Forlani in un discorso del 72 a La Spezia aveva denunciato la pericolosità dell’offensiva reazionaria), sia per la coraggiosa attività di alcuni magistrati, come Vittorio Occorsio che aveva messo fuori legge Ordine Nuovo, e dopo di lui Mario Amato, entrambi uccisi dai neofascisti.
Sei anni dopo i tragici eventi di Brescia, fu Bologna ad assurgere a teatro di un’altra strage, la più efferata nella storia del nostro Paese, ancora una volta realizzata “non solo con l’attiva complicità e la copertura, ma con la condivisa pianificazione da parte di organi e apparati vitali dello Stato”.
85 morti, 200 feriti e una serie di processi da cui ancora non è scaturita la verità definitiva: sono stati condannati gli esecutori dell’attentato (Fioravanti, Mambro, Cavallini, Ciavardini, Bellini), tutti gravitanti nell’area di estrema destra, che dopo lo scioglimento di Ordine nuovo e di Avanguardia nazionale (nel 1973 e nel 1976), si era riorganizzata a livello nazionale, trovando sempre nel Veneto un ricettacolo operativo e ideologico di rilievo. Dianese e Bettin ipotizzano una collaborazione attiva da parte del veneziano Gianpietro Montavoci, esperto di esplosivi, reclutato come informatore dai servizi segreti con il nome in codice di Mambo, uomo di fiducia del leader triveneto Maggi (condannato in via definitiva per la strage di Brescia e dentro tutte le trame dell’epoca). Varie sentenze processuali avevano poi indicato in Licio Gelli, l’ex Gran maestro della Loggia massonica P2, il mandante della strage con la collaborazione di Federico Umberto D’Amato, ex capo dell’Ufficio affari riservati del ministero dell’Interno, e di Mario Tedeschi, ex senatore del Msi ed ex direttore del settimanale “Il Borghese”. Precedentemente erano stati condannati per depistaggio delle indagini lo stesso Licio Gelli, il collaboratore del Sismi Francesco Pazienza, gli ufficiali del Sismi Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte. La Procura generale ha poi ricostruito i flussi di denaro utilizzati per finanziare la strage, distratti da Gelli da conti del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi (circa dieci milioni di dollari).
L’ attività criminosa della P2, insieme alla penetrazione gelliana nella finanza, nelle banche e nell’editoria, con l’asservimento del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, è riconducibile ai piani atlantici di prevenzione dell’espansione del comunismo in Europa, con l’impiego della controguerriglia psicologica che prevedeva anche il ricorso a stragi e pro vocazioni nelle varie forme delineate dall’operazione Chaos. Tale operazione era stata programmata dalla Cia e sviluppata nel 1967 su impulso del presidente Johnson per disorientare i movimenti degli anni 60 e 70 e le sinistre in tutto il mondo.
Malgrado queste cospirazioni internazionali e tutto il sangue innocente sparso, “il riformismo italiano ha prodotto frutti importanti: lo Statuto dei lavoratori, il Servizio sanitario nazionale, la riforma del diritto di famiglia, il divorzio, l’aborto, la riforma psichiatrica, l’obiezione di coscienza e il superamento del servizio militare obbligatorio, l’allargamento generale della sfera dei diritti e della partecipazione politica”. Di fronte all’avanzare delle destre e del sovranismo in Italia e nel mondo, “bisogna, di nuovo, cavalcare insieme alla tigre”, opponendosi al ritorno delle ombre oscure e feroci che hanno dilaniato la storia del secolo scorso e minacciano il progresso civile di quello attuale.
© Riproduzione riservata «Gli Stati Generali», 10 dicembre 2023
nato,