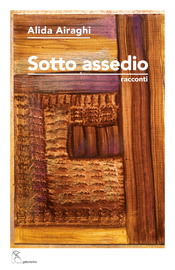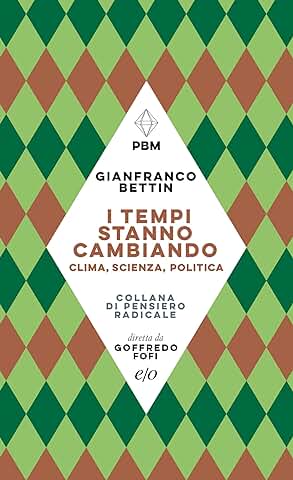VINCENZO FIORE, EMIL CIORAN – NULLA DIE, PIAZZA ARMERINA 2018
Nel 2018 la casa editrice siciliana Nulla Die ha pubblicato il volume di Vincenzo Fiore Emil Cioran. La filosofia come de-fascinazione e la scrittura come terapia. Vincenzo Fiore (Solofra, 1993) è un giovane filosofo e romanziere, collaboratore di riviste e quotidiani, membro del Progetto di ricerca internazionale dedicato a Emil Cioran. A buon diritto, e con assoluta competenza e passione, ha firmato questo esaustivo saggio, ricchissimo di note, corredato da una bibliografia e da un’appendice riportante una lettera autografa del filosofo romeno, tre ritratti fotografici e un articolo della giornalista venezuelana Carol Prunhuber.
Il libro si compone di tre capitoli, il primo dei quali ripercorre l’esistenza di Cioran dalla nascita in Transilvania nel 1911 alla morte a Parigi nel 1995: interessantissimo perché oltre a informare il lettore in maniera dettagliata su ogni avvenimento pubblico e privato della sua travagliata esistenza, garantisce puntualmente la veridicità dei fatti con testimonianze ricavate da lettere, interviste, brani tratti dalla sua produzione libraria e da interventi critici dei molti studiosi che di lui si sono occupati.
La parallela distribuzione tra notizie biografiche e il pensiero di Cioran è supportata proprio da un’affermazione del filosofo: “Tutto ciò che ho affrontato, tutto ciò di cui ho discorso per tutto il tempo della mia vita, è indissociabile da ciò che ho vissuto. Non ho inventato nulla, sono stato soltanto il segretario delle mie sensazioni… In fondo, tutti i miei libri sono autobiografici, ma di un’autobiografia mascherata”.
Nato a Rasinari, un villaggio di cinquemila abitanti situato nei Carpazi, Emil Cioran era il secondogenito di una famiglia istruita benché di modeste condizioni economiche. Il padre era prete ortodosso, e venne arrestato dalle autorità ungheresi insieme alla moglie con l’accusa di separatismo. L’infanzia di Emil fu quindi tormentata, tra separazioni e frequenti trasferimenti, e continuamente ossessionata dall’idea della morte, soprattutto a causa della sua acuta sensibilità, portata all’introspezione e alla malinconia. “Tanta febbre, tanta estasi e tanta follia”, ebbe a scrivere ricordando i suoi turbamenti giovanili, lo smarrimento di fronte agli avvenimenti politici, la sofferenza continua per l’insonnia, lo studio esaltato di argomenti religiosi – in particolare sul misticismo medievale -, di musica, di lingue straniere. Laureatosi nel 1932 con una tesi sull’intuizionismo di Bergson, l’anno successivo pubblicò il suo primo libro in lingua romena, Al culmine della disperazione, che metteva in luce la sua angoscia per la futilità della vita, il totale nonsenso di ogni attività quotidiana, la corruzione morale dell’essere umano. In quegli anni giovanili, si avvicinò a posizioni reazionarie e antisemite, convinto che l’ascesa al potere di Hitler potesse risvegliare la Romania dallo stato di abbrutimento politico ed etico in cui si era assopita per secoli, grazie a una sorta di trasfigurazione che dovesse favorire l’avvento di una “nuova umanità”. Tali posizioni ideologiche furono poi rinnegate dal filosofo con vergogna e pentimento, soprattutto dopo il suo volontario esilio in Francia a partire dal 1940.
Da questa data in poi, l’esistenza di Cioran non conobbe eventi biografici particolarmente traumatici, essendo totalmente dedicata alla riflessione filosofica e alla scrittura. Nel 1942 conobbe Simone Boué, giovane insegnante che rimase al suo fianco per tutta la vita, con cui alla fine della guerra si stabilì definitivamente a Parigi con lo statuto di apolide, adottando la lingua francese nella comunicazione quotidiana e in ogni scritto. Ritornato sulle posizioni teoretiche della sua giovinezza, addirittura radicalizzate, diede avvio a una personale crociata intellettuale contro il cristianesimo, la filosofia classica e le ideologie contemporanee. Con uno stile che lo assimilava a Nietzsche, non scrisse trattati sistematici, servendosi invece di aforismi e frammenti di prosa, rifiutando sia ogni rigida strutturazione sia qualsiasi artificio linguistico. Nel negare autenticità ai filosofi dogmatici e agli accademici, Cioran affermava che esistono solo due grandi questioni gnoseologiche: come sopportare la vita e come sopportare se stessi. L’unica pratica filosofica esercitabile era per lui lo scetticismo, come de-fascinazione, eliminazione di tutte le ideologie e astrazioni concettuali, in favore del vissuto rispetto alla teoria. Gli obiettivi polemici che il filosofo si pose furono quelli della negazione della Provvidenza e di un Dio creatore e benefico (Il funesto demiurgo, 1969), il contrasto al fanatismo ideologico e al totalitarismo, lo scandalo della nascita, ancora più dolorosamente negativa della morte (L’inconveniente di essere nati, 1973). Il totale pessimismo del suo pensiero lo avrebbe probabilmente condotto al suicidio già in giovane età, se non avesse trovato nella scrittura una partica auto-terapeutica che serviva a differire l’idea punitiva della fine volontaria.
Il merito di Vincenzo Fiore è di aver saputo ricostruire, attraverso un linguaggio accessibile a tutti, lineare ed elegante, evoluzioni e involuzioni del pensiero di Cioran, appoggiandosi non solo alla propria appassionata interpretazione, ma anche alle numerose e approfondite analisi di critici non sempre benevoli verso le provocatorie e polemiche tesi dell’antifilosofico filosofo romeno.
© Riproduzione riservata SoloLibri.net 16 novembre 2023