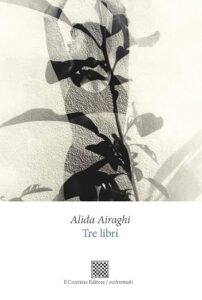I
Niente succede a caso, niente.
Che io ti abbia trovata, Euridice,
che tu sia apparsa a me – felice
di essere scoperta tra la gente –
un giorno non qualunque
di un non qualunque anno,
pronta a svelarmi inganno e disinganno;
per cui nel riconoscerti «Dunque
sei tu», nient’altro, e basta:
una stretta di mano, la mano
nella mia tiepida appena, casta,
e la voce che trema e non osa
dire quello che sa, ma piano
suggerisce altre cose, altra cosa.
II
E’ stata quindi una necessità
incontrarti, te tra millecento
che potevo, te pioggia sole vento
e subito me stesso, mia metà.
Più mia del mio sorriso e della pena,
più mia della parola, di ogni gesto.
Nome che chiamo, nome manifesto,
sangue che pulsa lento nella vena.
Perché sei tu e non altra, tu, Euridice,
compagna e sposa mia, sorella mia,
incisa nella pelle, cicatrice,
che mi riempi pensiero, bocca, sesso,
e non capisco ancora come sia
che perdo me nel ritrovarti, adesso.
III
Ascoltatemi, animali e voi piante,
tu cielo – monti torrenti scarpate –
voi cose sospese e interrate,
cose che mi girate intorno, tante.
Di certo non avrei mai creduto
di afferrare l’esistente con un dito:
se mi sento diventare infinito
e poi limite e fine, sordo e muto.
Euridice, continuo a nominare,
Euridice che canto e che invento,
Euridice, mio eterno pensare.
Siamo in due, siamo due e uno solo:
esserti fuori o dentro è tormento
in cui affondo. E poi volo.
IV
Può finire un amore, può cessare
di scorrere il sangue, così improvvisamente,
bloccarsi un corpo, tacere una mente,
e dicono non ci sia nulla da fare.
Io ti scuoto e ti scuoto, Euridice,
non è possibile che non mi rispondi
lì dove sei finita e ti nascondi,
tornata sottoterra, mia radice.
Ê uno scherzo, non può essere vero
che rimanga di te solo il dolore:
tutto intorno più nero del nero.
Per questo alzati, cara, non fingere
un silenzio adirato, accusatore.
Non restartene lì come una sfinge.
V
Andrò da maghi a vendermi il destino,
carte false farò con fattucchiere,
annegato nell’acqua di un bicchiere
perché non ci sei più, non ti ho vicino.
Maledetti gli dei; quell’uno solo
che ha deciso dall’alto del suo alto
– indifferente a tutto, ad ogni soprassalto
del cuore, trionfante nel suo ruolo –
di lasciarti morire, Euridice,
che non gli hai fatto niente,
mia figlia e sposa, amica mia, nutrice:
lo maledico con tutto me stesso,
dio colpevole e te innocente,
per quello che ha voluto, che ha permesso.
VI
Se provassi a pregare, se riuscissi
a convincerlo? Lui può fare
che sia quel che non è, può fermare
la terra, il sole, inventare un’eclissi.
Dio degli dei, dio dei viventi, dio,
non c’è un motivo vero, una ragione
per cui la vita mi diventi prigione,
e quello che era mio non sia più mio.
Ti scongiuro, signore dell’abisso,
ti imploro, lascia che ritorni
a fare uno di me che sono scisso.
Del tutto vero quello che si dice:
sono pronto a dannare i miei giorni
per riportarla a me, Euridice.
VII
Verrò a prenderti, cara, verrò
a liberarti, Euridice sprofondata
in un sonno ingannatore; mia malata,
rinuncerò a curarti, se vedrò
che ti avvolgi in un buio più profondo.
Cosa ti tiene, che cosa ti trattiene
laggiù, lontana dal mio bene:
hai paura di perderlo nel mondo?
Ma io scendo, comunque, a salvarti:
perché la vita vera è qui, è ora,
nel mio presente, nel mio sempre pensarti.
Non c’è assoluto che sia meglio
di noi, del mio volerti ancora.
Ed è un incubo il sonno in cui sto sveglio.
VIII
Sono pronto a fare una promessa,
barattando il mio sguardo col respiro
di te viva, il mio silenzio-capogiro
col tuo nome: Euridice principessa.
Giuro che non ti sfioro con gli occhi,
con le mani, che non mi avvicino
col mio corpo teso di bambino
incantato dal paese dei balocchi:
purché tu, semplicemente, sia
rimarrò muto, cieco e sospeso
vivendo viva e vera la magia
del tuo ritorno; impazienza
di averti, avendoti preteso,
mia ombra inconsistente, mia esistenza.
IX
Ecco, ti sento, ci sei e sei vicina.
Ma non ti guardo, taccio, sono bravo.
Ai tuoi occhi sarò padrone e schiavo,
Euridice, mia madre e bambina.
Come vorrei mi prendessi la mano,
toccarti un braccio, sfiorarti la bocca:
so che non devo, so cosa mi tocca
se non resisto a starti lontano.
Sei silenziosa e ferma al mio fianco,
oppure ti nascondi, resti indietro;
segui ubbidiente il mio passo stanco
e nel tuo passo leggero ti ascolto.
Tu, trasparente pensiero di vetro:
voglio appannarti. Ecco, mi volto.
In Litania periferica, Manni, Lecce 2000, in Nuovi Poeti Italiani 6, Einaudi, Torino 2012 e in Tre libri, Il Convivio 2025.