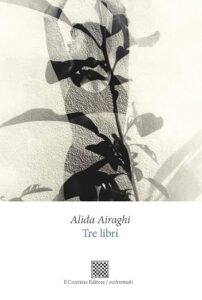GIOVANNA BEMPORAD, ESERCIZI VECCHI E NUOVI – SOSSELLA, BOLOGNA 2011
L’editore Luca Sossella rende un doveroso e meritato omaggio alla poetessa Giovanna Bemporad, nota e stimata traduttrice, pubblicando i suoi versi sparsi in diverse e ormai non più recuperabili raccolte, alcune risalenti a più di sessant’anni fa. Poesie di una raffinata e preziosa classicità, eleganti e misurate, di limpidissima e controllata sapienza. Già scorrendo l’elenco delle pluripremiate traduzioni dell’autrice, si prova un reverenziale rispetto: Omero, Virgilio, Goethe, Novalis gli autori più importanti di cui si è nutrito il suo timbro poetico, pervaso nella produzione personale dalla severa consapevolezza di chi è «alla perpetua ricerca del suono della perfezione», come suggerisce la postfazione. Quindi, una poesia intrisa di tradizione, nei suoi incipit quasi sempre votati all’endecasillabo, mai scontato e troppo cantabile, ma sempre denso di significati, che subito introduce il lettore al senso più intimo del verso: «Mia compagna implacabile, la morte», «Nelle mie vene, un tempo ebbre di vita», «Gioventù, mio rammarico inesausto», «L’anima mia che ha tristezze d’aurora». Alcuni versi sono limpidamente e apertamente modulati su quelli famosissimi dei nostri lirici: di Montale, per esempio, «Non domare, implacabile, il mio riso / mentre il fiore del melo incanutisce; / non recidermi il filo dei pensieri…», o di Leopardi: «E come il vento / su per roseti rampicanti in fiore…», e ancora «meglio piegarsi a immagine di un fiore / che docilmente all’urto dell’inverno / si spoglia dei suoi petali», «sarebbe dolce / svanire in questa immensità serena». Leopardiane sono senz’altro le atmosfere di questi idilli contemporanei: con la luna (bianchissima, casta, dolce, insensibile, perfida, sola e dolorosa), il mare ( giovane, clamoroso, pigramente verde), il vento ( blando, di antiche età, rude ), la notte ( eterna e chiara). Ma soprattutto l’ombra, l’ombra che si diffonde in moltissime poesie, accompagnando il calar del sole o dilagando sotto le fronde degli alberi, metafora del tempo che si consuma, e di un implacabile avvicinarsi della morte. La fine della giovinezza viene cantata con rassegnata malinconia, e l’attesa di un dissolvimento nel nulla non ha niente di tragico, e assomiglia invece a un placido abbandonarsi al sonno: «come s’infrange un’onda nella calma», «La luna va calando all’orizzonte / dove si perde la pianura, e dice / che trapassare al nulla non è male», «Dolore, che mi seguiti immortale / e indomabile fino al limitare / della morte, avrò gioia dagli spazi?»
Quest’impressione di «ariosa calma», questo tranquillo e fiducioso affidarsi ai silenzi della natura e del cosmo, nei paesaggi notturni e acquatici che tanto ricordano l’immobile serenità delle stampe cinesi, rifuggono dall’esibizione di qualsiasi sfrontato richiamo autobiografico. Anche le poesie d’amore, pervase da una sensualità delicata e da un’armonia lontana da ogni smodata passione, si offrono al lettore con lo stesso pudore e incantata gratitudine con cui descrivono le fanciulle amate: «o ninfa, o baiadera, / non che adirarmi col vento d’amore / sospendo ai tuoi squillanti braccialetti / e alle tue lunghe mani una bianchezza / di mute solitudini, e il tuo collo / sfioro con disarmati occhi indolenti». L’eco di Saffo è dichiarata, ma si sente tutta l’eredità maturata nei secoli dai lirici latini fino ai provenzali e forse al nostro Penna: «Conduci al convegno quella ch’io amo / e non trapassi inconsumata l’ora / o notte. // In solitudine confusa, / dimentico tra me ch’ella è partita / e al luogo del convegno aspetto sola». Una voce purissima, dunque, che ha taciuto a lungo negli anni urlati degli sperimentalismi recenti, e che pure prova strategie compositive nuove e coraggiose, come nella ricerca degli attributi, spesso stranianti: fronte smemorata, insondabile azzurro, divieto acerbo, trionfanti primavere, bellezza acquatica, bruno languore, sabbia mortuaria, ora aggravata, volante cuore, alba abortita, oggetti quieti e sedentari…
Questa altissima poesia di Giovanna Bemporad rappresenta un severo ammonimento, un insegnamento consapevole della sua grandezza per la poesia italiana di oggi, così presuntuosamente soddisfatta di esibire obiettivi minimi, atmosfere banali, impoverimenti lessicali, ed è di sprone a una più impegnata profondità.
«Leggere Donna» n.154, gennaio 2012