LUCA DONINELLI, L’IMITAZIONE DI UNA FOGLIA CHE CADE – ABOCA EDIZIONI, SANSEPOLCRO 2020
L’azienda toscana Aboca, fondata nel 1978, si occupa di cura della salute creando e vendendo prodotti alimentari e cosmetici naturali, che rispettano l’organismo e l’ambiente. Promuove anche attività culturali, attraverso l’organizzazione di eventi, convegni, mostre, e la pubblicazione di libri: da poco ha inaugurato una collana di narrativa in cui autori italiani di successo (Abate, Parazzoli, Villalta…) pongono al centro del loro testo il rapporto con la natura e il mondo vegetale.
In questo spazio a indirizzo “ecologico” è da poco uscito L’imitazione di una foglia che cade, di Luca Doninelli, racconto di un centinaio di pagine, il cui protagonista è un maturo e affermato scrittore lombardo, Ugo, impegnato in una rivisitazione della propria vita, che lentamente si trasforma in un severo inventario di cedimenti intellettuali e ammorbidimenti morali.
Tornato single dopo la separazione dalla moglie e dai due figli, dedica il suo tempo non solo alla lettura e alla scrittura, ma anche a un’attenta e approfondita disamina di ogni accadimento, materiale o spirituale, si affacci a scalfire la sua quotidianità: dalle difficoltà di un trasloco, alla casuale caduta di un tomo dallo scaffale, a un qualsiasi incontro fortuito. Ogni oggetto gli parla, ogni azione lo interroga: “Mi piace decifrare. Per me il fruscio di un ramo è un discorso, come lo sono il rumore di un aereo che passa sulla mia testa o il battito di un martello pneumatico in un cantiere lungo una via cittadina. Un tram è una lingua, come lo sono i volti di chi lo occupa, i loro abiti e le loro scarpe. Lingua è un ciuffo d’erba che spunta tra una carreggiata e un marciapiede, la cornice di una finestra, la velocità delle automobili su un viale di scorrimento”.
A un personaggio tanto introspettivo, può senz’altro apparire miracoloso e rivelatore l’arrivo inatteso di un pacchetto contenente un libro che gli era appartenuto, l’Historia Francorum di Gregorio di Tours. Sulla busta si legge solo un indirizzo, “Piazzale Martini, Milano”, privo di mittente. Sfogliando le pagine ingiallite del volume, scopre che all’interno della rilegatura è nascosto un quaderno su cui, ancora ragazzo, aveva scritto con grafia minuta e ordinata il suo primo romanzo, mai pubblicato: Gli incurabili. Inoltre, dal quaderno spunta una vecchia foglia d’acero, scura e indurita. Nel riconoscere in entrambi gli oggetti testimonianze del suo passato, Ugo è colto da un sentimento di disagio, sospeso tra gioia e timore. “La lettura di quelle mie pagine ingenue mi ricondusse non soltanto a un mondo che avevo perduto ma anche a un certo modo – non meno perduto – di stare al mondo. Avrei potuto passare ore e giorni a segnare tutti gli errori del manoscritto, ma sapevo che questo non avrebbe dissipato l’impressione di avere lasciato, proprio lì, la parte migliore di me”.
Ovviamente, la parte migliore della sua esistenza viene individuata negli slanci, nelle utopie, e nell’ingenuità della giovinezza. Ugo si rivede studente universitario, innamorato della letteratura, circondato da amici come lui impegnati a rifondare la società, immersi nella lettura di Barthes, Foucault, Derrida. La prima fidanzata, l’incontro con la moglie Valentina, gli anni economicamente precari e professionalmente problematici del matrimonio, l’ambizione di agire e scrivere in modo radicalmente intenso e incisivo. Come, dove, quando tutto ciò era andato perduto? Perché l’intransigente purezza di allora era scesa a compromessi? “Voglio solo dire che la letteratura fu responsabile, in qualche modo, del mio disastro. Una volta diventato scrittore per tutti, una volta raggiunto questo status, le mie parole cominciarono infatti a viaggiare alla velocità del mondo – senza tuttavia appartenergli – e io viaggiavo alla velocità delle mie parole, e quindi del mondo”.
All’epoca frequentava una bancarella di libri in Piazzale Martini, il cui proprietario era un anziano signore francese, Monsieur Pineau, saggio dispensatore di consigli di lettura e di vita. Al vecchio libraio, Ugo aveva venduto uno scatolone dei suoi volumi, tra i quali appunto quello di Gregorio di Tours che ora gli veniva misteriosamente restituito, con le tracce di un’esistenza ormai lontana, macchie di caffè e una foglia di acero come segnalibro. Torna quindi a cercare Pineau, ormai ultraottantenne, ma sempre seduto sulla sua poltrona, davanti alla bancarella: “un vero e proprio salotto letterario all’aperto, con uno stuolo di frequentatori perlopiù giovani e poveri”: ascolta umilmente i rimproveri di lui, e ne accoglie con discrezione le confidenze. Principalmente, quella di un incontro con un profetico, amaro e visionario Roland Barthes, capace di leggere le parole sospese nel vuoto mentre vengono pronunciate. La morte del filosofo francese si intreccia con quella di Pineau, il funerale di quest’ultimo, a cui partecipano molti intellettuali milanesi, svela nell’animo turbato di Ugo che a ogni vuoto, a ogni precipizio, a ogni fine, corrisponde un pieno di vita e di amore.
Ne sono testimoni i nostri guardiani alleati, le creature inoffensive e verdi che ci circondano e sanno tutto di noi. Gli alberi del cortile di fronte, delle pianure, dei boschi; le foglie che cadono, e quella di acero ora incorniciata in una teca di plexiglas, suscitatrice di memorie, ancoraggio a un passato che non va rimosso, ma custodito con gratitudine.
© Riproduzione riservata «SoloLibri», 2 febbraio 2020
https://www.sololibri.net/L-imitazione-di-una-foglia-che-cade-doninelli.html

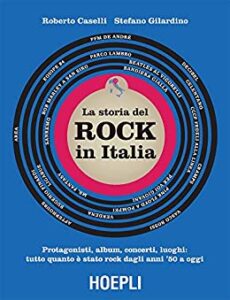
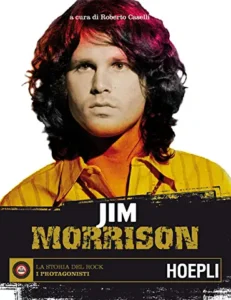
 cantautori storici Luigi Tenco, Paolo Conte, Francesco De Gregori, Ivano Fossati e Gino Paoli che ha dato il via alla stagione. Tra le nuove generazioni mi piace Brunori Sas anche se ormai non è proprio quel che si dice un ragazzino.
cantautori storici Luigi Tenco, Paolo Conte, Francesco De Gregori, Ivano Fossati e Gino Paoli che ha dato il via alla stagione. Tra le nuove generazioni mi piace Brunori Sas anche se ormai non è proprio quel che si dice un ragazzino. dei musicisti che lo interpreta si auto-produce e proprio per questo può permettersi di essere uno dei potenziali esempi di critica sociale più efficaci.
dei musicisti che lo interpreta si auto-produce e proprio per questo può permettersi di essere uno dei potenziali esempi di critica sociale più efficaci.