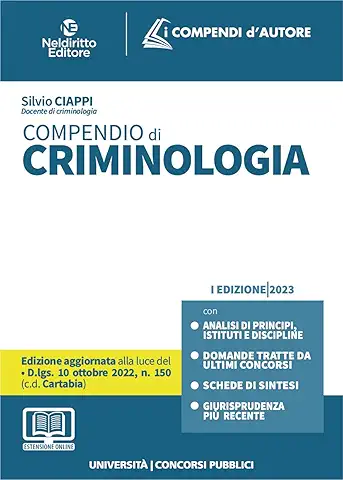Silvio Ciappi, psicologo e criminologo, laureato in Giurisprudenza a Siena e poi in Psicologia a Roma, si è specializzato successivamente in criminologia clinica, psichiatria forense e psicoterapia. È docente di materie criminologiche e psicologiche in diversi atenei italiani e scuole di specializzazione e ha svolto corsi di formazione e seminari per conto del Consiglio Superiore della Magistratura, per il Ministero della Giustizia e in molte università straniere. Si è occupato di reati violenti, di psichiatria e psicopatologia forense, di psicologia clinica e giuridica, di sociologia della devianza e di tematiche legate alla prevenzione dei delitti e alla sicurezza. Ha svolto consulenze forensi per alcuni dei più importanti casi di cronaca giudiziaria italiana. Nel 2021 è stato nominato Consulente della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla morte di David Rossi, manager MPS. Ha svolto missioni internazionali in America latina, Africa ed Asia in tema di prevenzione della criminalità, giustizia riparativa, politiche sociali e valutazione dei sistemi giudiziari per conto della Commissione Europea e di altre istituzioni e centri di ricerca italiani e stranieri, occupandosi di narcotraffico, terrorismo internazionale, diritti umani, politica criminale e della giustizia. È stato uno dei primi studiosi a occuparsi di giustizia riparativa in Italia con esperienze di mediazione dei conflitti anche all’estero. È noto soprattutto per l’applicazione del metodo narrativo in ambito psicopatologico e per i suoi contributi centrati sull’analisi dell’approccio narratologico e traumatologico alla spiegazione del crimine. È anche scrittore e autore di romanzi noir (Il Missionario e L’uomo dei lupi).
Tra le sue opere:
Periferie dell’impero. Poteri globali e controllo sociale, Derive&Approdi, Roma 2003 (con contributi di Zygmunt Bauman, Joseph Stiglitz, Luciano Gallino, Alex Zanotelli, Naomi Klein ed altri; Idoli della Tribù. Politiche della sicurezza e controllo sociale, Piero Manni Editore, Lecce 2004; Orrori di provincia. Serial killer, assassini e pedofili dell’Italia profonda, Mondadori, Milano 2005; Il Vuoto dietro. Esercizi di anticriminologia, Rubbettino, Catanzaro 2010; Anime nude. Finzioni e interpretazioni intorno a 10 poeti del Novecento, Mauro Pagliai Editore, Firenze 2011; Ritratto di una mente assassina. Trauma, attaccamento e dissociazione in un killer seriale, Franco Angeli, Milano 2015; Coca Travel. Viaggio sentimentale di un criminologo lungo le rotte dei narcos, Oltre, Genova 2016; L’uomo che non voleva morire. Storia di un pescatore di anime, Gabrielli, Verona 2017; La Mente Nomade. Metodo narrativo-relazionale e costruzione dell’identità in psicopatologia, Mimesis, Milano 2019; Manuale di Criminologia, Nel Diritto Editore, Molfetta (BA) 2021; Odio. L’altra faccia del dolore, Giunti, Firenze 2023; Predatori. Dahmer, Bilancia e altri serial killer, Giunti, Firenze 2023; Il Branco. Storie di giovani, di violenza e di noia nel mondo orizzontale, Giunti, 2025, in corso di pubblicazione).
· In una formazione giuridica e psicanalitica così severa e impegnativa come la sua, che spazio ha potuto ritagliarsi l’allusività della parola poetica? A quando risale il suo interesse per la letteratura, e come viene incrementato anche oggi?
E’ stata di fondamentale importanza sia la letteratura che la poesia nel mio percorso di studi. Consideri che ho un percorso di studi universitario, purtroppo per pochi esami non fondamentali non terminato, in lettere classiche. Ritengo che la potenza della parola poetica sia fondamentale. In fondo tutta l’attività psicologica non è che una variazione tecnica sul tema della poesia. Devi trovare la parola giusta, quella che permette al paziente una visione più realistica di se stesso. Le parole creano. Guarda un po’ l’etimo. La parola poesia deriva dal verbo greco ‘poieo’ che significa ‘fare’, ‘costruire’. Si, ma in sostanza cosa si ‘costruisce’ con la poesia? Fabbrichiamo parole cariche di senso, le uniche a portarci dritte nel nostro mondo interiore e descrivercelo meglio, diamo un nome ai sentimenti e se le cose hanno un nome acquistano una identità. I versi possono essere il modo di medicare i nostri mali. Esistono anche parole che facciamo fatica a pronunciare. Scopo di una terapia è farle venire fuori anche se spesso hanno un costo improponibile. Oggi più che mai c’è bisogno di parole e l’insegnamento della letteratura e della poesia può essere d’aiuto per le giovani generazioni. Aiutarle a credere che il mondo che li circonda oppure quello che hanno dentro possa essere descritto e che c’è stata gente che riesce a farlo, i poeti, i cantanti, gli scrittori, e che se vogliamo possiamo farlo anche noi. Anche i social potrebbero essere d’aiuto in questo. Non basta sapere come quando e cosa ha fatto Leopardi, quando piuttosto comprendere cosa si agitasse nella testa di quel ventenne quando si immaginava quell’infinito, il suo, il nostro, in cui perdersi.
· In un volume del 2011, Anime nude, si è occupato di interpretare dieci poeti novecenteschi. Chi di questi ha avuto un riverbero maggiore in lei, culturalmente e sentimentalmente?
Indubbiamente Anna Achmatova e la grande poesia russa hanno avuto una grande influenza su di me. Nel libro mi sono immaginato quell’incontro unico tra la grande poetessa russa e Amedeo Modigliani, quel loro amore, benché lei fosse lì in viaggio di nozze e lui uno spiantato pittore italiano alla ricerca di fortuna. Mi sono immaginato quell’amore che era fin dall’inizio un amore impossibile, ma si sa solo gli amori possibili sono quelli che restano. Parlo dell’amore perché è il corrispettivo dell’odio, l’altra faccia nella quale possiamo relazionarci con l’altro. E il tema della relazione è fondamentale. Abbiamo bisogno di un altro che ci riconosca, solo tramite il riconoscimento dell’altro riusciamo a sviluppare una identità: tu mi guardi, tu mi parli, io mi riconosco. Siamo al tempo stesso attori e spettatori della vicenda umana.
· Nella sua vastissima esperienza di scandaglio della psiche e dell’animo umano, ritiene che la poesia possa rivestire un ruolo non solo di scavo e consapevolezza interiore, ma anche di recupero di sensazioni positive rimosse, riparatrici del dolore, ancoraggio esistenziale?
La poesia è un potente antidolorifico, se mi permette la battuta. Lenisce il dolore nel momento in cui riesce a dare voce al borbottio interiore. Come ha scritto un autore che a me piace molto, siamo dieci per cento biologia e novanta mormorio notturno. E in quel mormorio notturno ci stanno immagini, sensazioni, parole. Prendi il dolore. Il dolore per essere in qualche modo contenuto deve essere narrato. Il dolore che non può essere narrato diviene annullamento, frammentazione, svuotamento interiore e rischia di diventare solo una perdita senza sofferenza, che può essere colmata anche attraverso la vendetta, la rabbia, lo scontro rivolto contro se stessi o contro l’altro. Il dolore è più sopportabile se invece lo inseriamo all’interno di una storia. Ma al tempo stesso non possiamo vedere la nostra storia, le orme che abbiamo lasciato sui sentieri, abbiamo bisogno di un’altra prospettiva e in questo può essere d’aiuto lo psicologo-narratore: noi siamo anche il racconto che altre persone fanno di noi. Un po’ come Edipo, come Ulisse, sono gli altri a raccontarci chi siamo. Accade anche che le parole del dolore a volte siano impronunciabili. La parola poetica ci permette questo. E’ uno sguardo obliquo sul mondo. Come diceva un grande filologo russo, Viktor Sklovskij, ci permette di ‘spacchettare’ il mondo e di dargli un senso diverso, inusuale. Mi verrebbe da dire: ‘hai mai pensato tu lettore a cosa accadrebbe se iniziassi a vedere il mondo, le persone che ti circondano secondo un altro angolo visuale? Provaci’. Le parole servono anche a ricucire, sono le parole-riparatrici che ci permettono una riscrittura interiore e che ci aiutano a saper stare al mondo nel disordine del vivere, affinché la vita non sia montalianamente che solo uno scialo di triti fatti.

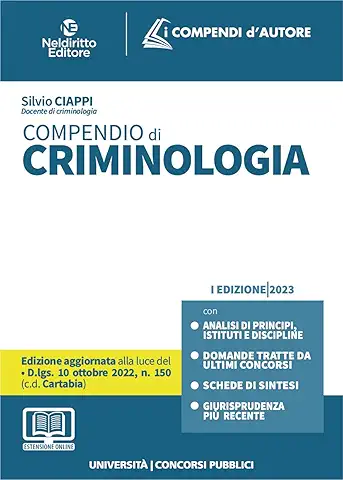
· Avendo frequentato carceri minorili e penitenziari, ha avuto occasione di rilevare se i reclusi abbiano confidenza con la poesia, come lettori o addirittura come produttori di versi, più o meno estemporanei?
Sì, a volte accade. Paradossalmente il tempo lento della reclusione fa sì che ci si possa addentrare, fuori dal tumulto della quotidianità, a fare i conti con se stessi. Siamo spesso troppo impegnati in letture ‘alte’ di noi quando invece sarebbe meglio conoscere l’inesauribile superficie delle cose prima di spingersi a cercare ciò che sta sotto. I luoghi della segregazione possono paradossalmente permetterci di fissare lo sguardo verso piccoli particolari, dettagli dell’esistenza, impressioni sensoriali che in altre circostanze ignoriamo. Il mestiere di vivere diviene un viaggio attraverso le piccole cose del nostro mondo, un viaggio nomade alla ricerca di quelle sillabe nascoste che ci hanno rappresentato e che ci invitano a vivere. La poesia è un dar voce alle nostre esperienze sensoriali, è cammino interiore che può riparare il nostro cielo di sentimenti.
· La visione romantica del poeta come déraciné, asociale, dissidente, risponde a realtà, in questi nostri tempi di premi salottieri, festival, competizioni ed esposizioni mediatiche? La poesia rimane voce indocile, estranea e indifferente alle lusinghe del potere?
Deve a mio modo di vedere starsene lontana dalle sirene del potere la poesia, ma anche le scienze dell’anima. La poesia è un modo umile di approcciare il mondo. Intendo dire non si prefigge una costruzione moralistica, non ha da insegnare o mostrare niente se non invitarci a raccontarci, a prenderci dieci minuti ogni dieci giorni, ma quei dieci minuti ci vogliono, nei quali facciamo i conti con noi stessi. Certo ci vorrebbe un altro che ci aiutasse a recuperare questo momento di quiete, di abbandono del quotidiano, che ci possa far recuperare un certo senso di tranquillità, ma se non c’è l’Altro può divenire una immagine di noi interiorizzata, l’Altro-poetico con il quale dialogare. Le parole-simbolo della poesia possono guidarci in questo movimento interiore, sono parole-stimolo che possono aiutarci a vederci in una duplice funzione: quella del vedere e dell’essere visto, quella del parlare e dell’ascoltare, del chiedere e del dare. Siamo un colloquio, un mormorio, con l’Altro che ci abita a metà strada tra l’essere e l’apparire. Tutto questo non ha niente a che fare con l’esibizionistica e moralistica voglia di apparire. Nel mondo della società-spettacolo come ha ben evidenziato Richard Sennett nel suo ultimo libro, anche la cultura e la poesia rischiano di spettacolizzarsi. Le discipline che frequento di più, la psicologia e la criminologia, lo stanno già facendo da tempo e i risultati sono noti a tutti: volgarizzazione dei contenuti, scienze ridotte a mere istruzioni per l’uso, riduzione della complessità per un linguaggio social o televisivo che sia diretto, efficace in modo che possa essere divulgabile e masticabile da una socialità ridotta spesso a branco, fisico o digitale che sia.
© Riproduzione riservata «Gli Stati Generali», 8 novembre 2024