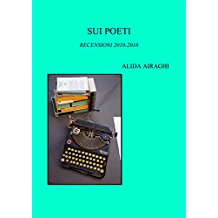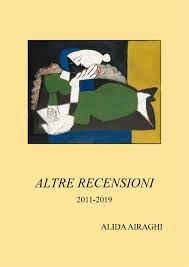GUSTAVE FLAUBERT, LETTERE D’AMORE A LOUISE COLET – SE, MILANO 2018
Chissà se André Gide diceva la verità, quando scrisse, a proposito dell’epistolario flaubertiano “Se l’opera intera di Flaubert dovesse essere messa su un piatto della bilancia, la sola Corrispondenza, gettata sull’altro, la supererebbe; e se mi fosse permesso di conservare soltanto l’una o l’altra, io sceglierei quest’ultima”. È certo comunque che queste Lettere d’amore a Louise Colet, pubblicate dalle edizioni milanesi SE, sono di una bellezza struggente, di un’accesa intensità emotiva, oltreché di superba raffinatezza formale.
Gustave Flaubert (Rouen 1821-Croisset 1880), autore di capolavori universalmente riconosciuti, aveva ventiquattro anni e solo vaghe ambizioni letterarie, quando nell’estate del 1846 incontrò Louise Colet nell’atelier parigino dello scultore Pradier, dove si era recato per ordinare due busti funerari per il padre e la sorella morta di parto, e dove lei posava come modella. Trentaseienne, sposata e madre di una figlia, già amante del filosofo Victor Cousin e corteggiata da molti, animatrice di salotti culturali, scrittrice e poetessa affermata, Louise era bellissima. Capelli castani lunghi e morbidi, occhi di un azzurro cupo, collo e spalle armoniosamente disegnati, voce suadente e sorriso aperto, temperamento altero e impulsivo: così descriveva sé stessa e veniva descritta dagli ammiratori. L’attrazione reciproca tra Gustave e Louise sfociò subito in una relazione tempestosa, fatta di slanci e rimproveri, premure e accuse, sensualità irruente e improvvise freddezze, animata da un fitto scambio epistolare, prolungatosi per una decina d’anni e scandito in due fasi: la prima, accanita e sofferta, dal 1846 al 1848, la seconda dal 1851 al 1855, più riflessiva e incentrata su temi intellettuali e letterari.
Il volume qui presentato riporta esclusivamente le lettere del primo biennio, in cui i due amanti si concessero solo sei incontri, interrotti spesso da scenate di reciproca gelosia e puntigliose recriminazioni. Successivamente, Flaubert si regalò distrazioni, viaggi, e un lungo periodo di formazione esistenziale e culturale in Medio Oriente, in Grecia e in Italia. Tornato dall’esperienza esotica psicologicamente trasformato e deciso a dedicarsi in maniera esclusiva alla propria arte, nelle più sporadiche e distaccate missive a Louise manifestava le sue teorie estetiche, vantando soprattutto la sua dedizione al romanzo che lo consacrerà a una fama mondiale. Il progressivo allontanamento tra i due si rivelò inevitabile. Gustave era appassionato ma incostante, incapace di rinunciare alle proprie abitudini domestiche, agli affetti familiari e alle amicizie, alle frequentazioni letterarie, all’ossessione della scrittura coniugata a un’ambizione divorante. Louise, femminilmente più istintiva e generosa, incline al sospetto e possessiva, era però disposta a sacrificarsi nel quotidiano pur di salvare l’impeto del rapporto amoroso.
Le lettere di lei sono andate perdute, o più probabilmente sono state distrutte: dovevano essere febbrili e ulcerate come l’inquietudine che la struggeva. La sua vendetta dopo l’abbandono venne consegnata a due romanzi, in cui scherniva le grettezze e gli egoismi dell’amante, mentre Flaubert si servì più scaltramente della vicenda sentimentale e dell’esperienza epistolare nella composizione del suo chef d’oeuvre, Madame Bovary.Le frasi e i saluti di commiato vergati da Gustave indicano il fervore che lo animava nei primi mesi della corrispondenza: “Addio, addio. Tutte le tenerezze che vorrai”, “Addio, addio, poso la testa sui tuoi seni e ti guardo dal basso in alto come una madonna”, “Addio, ti bacio dove ti bacerò, là dove ho voluto. Vi ci metto la bocca, mi rotolo su di te, mille baci. Oh! dammene, dammene!”, “Tuo, dalla sera al mattino, dal mattino alla sera”, “Tuo, tuo corpo e anima”, “Ho ancora sete di te. Non sono sazio, sai! Addio, addio”, “Tuo che ami e che t’ama”, “Addio, tuo, su di te”, “Che il Dio dei sogni ti mandi da me”.Tanta passione inizia però a raffreddarsi già nel secondo anno della relazione, i baci diventano più casti e quasi fraterni, per poi ibernarsi del tutto nel saluto del biglietto conclusivo, quando da tempo i due si davano ormai del “Voi”: “Grazie del dono. Grazie dei bellissimi versi. Grazie del ricordo. Vostro.” (Flaubert non si firmava, forse per prudenza verso lo stato coniugale dell’amante).Le lettere scritte quotidianamente nei primi mesi seguiti al loro incontro, indicano quanto intenso e radicato fosse il trasporto del giovane verso l’affascinante dama parigina: è divertente notare come i messaggi reciproci venissero recapitati in giornata, nonostante la distanza tra Croisset, in Normandia ‒ dove lui risiedeva con la madre, il fratello, il cognato e due nipotine ‒, e la capitale dove viveva lei con marito e figlia. Incredibilmente, così Gustave raccomandava a Louise: “quando mi scriverai la domenica, impostala presto; sai che gli uffici chiudono alle due”. Qual era il valore di queste pagine per Flaubert? Quasi feticistico; le conservava in un cassetto come reliquie, insieme al fazzoletto, alle pantofoline, a una ciocca di capelli dell’amata: “le rileggo, le tocco. Una lettera è come un bacio, l’ultima è sempre la migliore. Quella di stamattina è qui. Fra la mia ultima frase e questa non ancora finita me la sono riletta per rivederti più da vicino e sentire più forte il profumo di te. Penso alla posa che devi avere mentre scrivi e ai lunghi sguardi vaghi che getti voltando le pagine. È sotto quella lampada che ha fatto luce ai nostri primi baci, e su quella tavola su cui scrivi i tuoi versi. Accendila la sera la tua lampada d’alabastro, guardane la luce bianca e pallida ricordando la sera in cui ci siamo amati”.Le manifestazioni di affetto sincero, di ammirazione, di desiderio fisico si alternano con considerazioni più generali sulla vita domestica, sulla morale (“Non cerchiamo tutti quanti di soddisfare la nostra natura secondo i nostri diversi istinti?”), o con valutazioni sull’arte (“Fra tutte le menzogne è ancora la meno menzognera”), sulla letteratura (“Non bisogna sempre credere che il sentimento sia tutto, nelle arti non è nulla senza la forma”), sulla propria scrittura (“Mi sono sempre proibito di mettere qualcosa di personale nelle mie opere, eppure ve ne ho messo molto. Ho sempre cercato di non rimpicciolire l’Arte per soddisfare una personalità isolata. Ho scritto pagine tenerissime senza amore, e pagine incandescenti, senza alcun fuoco nel sangue”, “Il grottesco triste ha per me un fascino inaudito. Esso corrisponde agli intimi bisogni della mia natura buffonescamente amara”).Rimane comunque preponderante in chi legge l’interesse per il vincolo che legava i due personaggi, la dedizione incondizionata di lei, e la difesa dell’indipendenza di lui, talvolta giustificata dall’esigenza di non lasciare sola l’anziana madre, più spesso (al di là di ogni appassionata dichiarazione d’amore) dalla consapevolezza del proprio ineliminabile egoismo, dell’allergia ai legami soffocanti, di un’orgogliosa autosufficienza emotiva.In una delle ultime lettere, seguita a un violento litigio, Gustave scriveva: “Avrei voluto amarti come mi amavi tu, ho lottato invano contro la fatalità della mia natura, niente, niente. Il cardo non è buono che per gli asini, tanto peggio per quelli che vi si sdraiano sopra come si fa su un prato… Io che amo sopra ogni cosa la pace e il riposo non ho trovato in te che il turbamento, burrasche, lacrime o collera… Hai voluto, tu, trar sangue da una pietra. Hai scalfito la pietra e ti sei fatta sanguinare le dita. Hai voluto far camminare un paralitico, il suo peso è ricaduto tutto su di te ed è diventato ancor più paralitico. No, non c’è acredine, né collera, né odio, ma un profondo e triste convincimento… C’è sempre una devozione pronta e, se la parola non ti ferisce, una smisurata gratitudine. Mi chiedi che almeno i nostri ricordi mi riportino qualcosa; ebbene, come la prima sera un casto bacio sulla fronte. Addio, immagina che sia partito per un lungo viaggio. – Ancora addio, incontra qualcuno più degno, per dartelo andrei a cercarlo in capo al mondo. Sii felice”.Poco prima del silenzio definitivo, Louise confida a Gustave – che non vedeva da molto tempo – una notizia inaspettata, probabilmente quella di una nuova gravidanza. Flaubert reagisce con educata comprensione ma sostanziale indifferenza: “Qualunque cosa accada contate sempre su di me. Anche quando non ci scrivessimo più, anche quando non ci vedessimo più, ci sarà sempre fra di noi un legame che non si cancellerà, un passato di cui sopravviveranno le conseguenze”.
Se Sartre nella sua severa biografia flaubertiana L’idiota della famiglia ebbe a definire l’odiosamato autore dell’epistolario “un incurabile nevrotico”, al lettore contemporaneo rimane invece l’impressione di aver disigillato attraverso queste pagine la natura scorticata di due anime sprofondate in un baratro di rancore e incomprensione mentre tentavano di raggiungere la vetta dell’intensità amorosa, pretendendo troppo da sé stesse e dal sentimento illusorio e spietato che le aveva unite.
© Riproduzione riservata «Il Pickwick», 20 giugno 2019