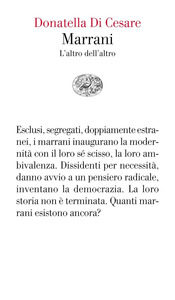EDGARDO FRANZOSINI, RIMBAUD E LA VEDOVA – SKIRA, MILANO 2018
Nella primavera del 1875 il ventunenne Arthur Rimbaud visse per quasi un mese a Milano, ospite di un’anziana vedova, in un appartamento affacciato su Piazza del Duomo. Proprio in quei giorni prese la decisione di abbandonare la scrittura, dando inizio a una nuova esistenza, sempre avventurosa e anticonvenzionale, ma non più votata al demone dell’arte. Edgardo Franzosini, scrittore lombardo nato nel 1952, ricostruisce minuziosamente quelle fatidiche giornate milanesi in cui il poeta che definiva sé stesso «ladro di fuoco», «fanciullo sfiorato dal dito della Musa», «veggente mediante un lungo, immenso e ragionato sregolamento di tutti i sensi», decise di trasformarsi in «qualcuno che era stato lui, ma che non lo era più, in nessun modo» (secondo le parole di Mallarmé), diventando mercante d’armi in Abissinia, dopo aver lavorato come inserviente di un circo, soldato mercenario, caposquadra in un cantiere e venditore di caffè e avorio in Europa, in Africa e in Medio Oriente
Franzosini è uno dei più originali scrittori italiani, ex bancario e oggi stimato autore Adelphi molto tradotto all’estero: ha scelto di indagare la vita misteriosa di personaggi più o meno noti, ma le cui vicende esistenziali sono rimaste avvolte in un velo di nebbia, oscurate da silenzi, calunnie, pregiudizi, persecuzioni. Come Bela Lugosi, interprete di film horror su Dracula; o l’avventuriero inglese Johann Ernst Biren, mangiatore di carta stampata; oppure il religioso Giuseppe Ripamonti, che scriveva i discorsi del Cardinale Federico Borromeo e venne da lui accusato di eresia e fatto imprigionare; o Raymond Isidore, costruttore di una cattedrale fatta di detriti e sporcizia; o ancora Rembrandt Bugatti, straordinario scultore di animali in bronzo e fratello infelice del fondatore di un prestigioso marchio automobilistico… Personaggi stravaganti e ai margini, a cui rendere dignità sulla pagina, attraverso un minuzioso lavoro di ricerche negli archivi, approfondite letture, precise ricostruzioni d’ambiente.
In questo volume pubblicato da Skira, Edgardo Franzosini si occupa invece di un artista famosissimo, genio precoce dalla vita girovaga e sregolata, che aveva scritto il Bateau ivre a diciassette anni e, nel giro di poco tempo, altri due capolavori: Une saison en enfer e le Illuminations. Ricostruisce la città che accolse il giovane Arthur utilizzando diverse fonti documentarie: giornali d’epoca, locandine teatrali, antiche guide turistiche, resoconti di fatti di cronaca e di vicende politiche. Una laboriosa Milano di 280.000 abitanti, che verosimilmente non rappresentava per il poeta la meta finale del viaggio, bensì una tappa intermedia, prima di raggiungere Civitavecchia o Brindisi per imbarcarsi verso la Spagna o le Isole Cicladi, nel suo errabondo e inquieto vagare in cerca di lavoro e di una sistemazione abitativa. Sappiamo da una lettera che mal sopportava la sua cittadina nelle Ardenne («La mia città natale è superlativamente idiota fra tutte le cittadine di provincia»), la borghesia ottusa e convenzionale che vi abitava, i familiari meschini e ignoranti. Come era arrivato a Milano? Camminando dal confine tedesco fino al Canton Ticino, attraverso il passo del San Gottardo; e poi da Airolo a Milano, per 200 chilometri, ancora a piedi (agile e resistente marciatore qual era), oppure in treno, ma clandestinamente, poiché del tutto sprovvisto di soldi. Del suo soggiorno nel capoluogo lombardo sono rimaste «impronte lievissime». In pratica, solo la copia di un biglietto da visita che riportava a caratteri di stampa il suo nome, a cui era stato aggiunto a penna un indirizzo: «39. Piazza del Duomo. Terzo piano. Milano». Ne diede testimonianza Ardengo Soffici in un saggio critico sul poeta francese, con dedica «Alla ignota Signora milanese che soccorse e forse amò Rimbaud, affamato vagabondo per l’Italia».
Basandosi su queste labili tracce, Edgardo Franzosini ha fabbricato un racconto sospeso tra realtà e leggenda, supposizioni e aneddoti. Chi era la dama che lo ospitò per quasi un mese nella sua casa in Piazza del Duomo? Era esistita veramente, come suggeriva con qualche morbosità Verlaine (che nel 1873, pazzo di gelosia, aveva sparato all’amante due colpi di pistola, finendo per questo in carcere)? L’adorato Paul scriveva: «Coso è a Milano, in attesa di denaro per la Spagna», alludendo poi a due episodi di amore eterosessuale dell’amico, uno a Londra e uno «con una vedova molto civile in quel di Milano». Anche il critico Ernest Delahaye citò «una signora caritatevole… una buona milanese», di cui era venuto a conoscenza attraverso una lettera di Arthur. La sorella di Rimbaud, Isabelle, e il marito di lei, strenui difensori dell’immagine rispettabile e virtuosa del poeta, a più riprese smentirono la frequentazione con una donna italiana, affermando che il loro caro viaggiava esclusivamente per impratichirsi nelle lingue straniere, a cui era portato per naturale e felice disposizione mentale. Se l’ospitale signora fosse vedova inconsolabile o no, se affittasse camere sul sagrato della cattedrale a turisti bisognosi, se si fosse fatta ricompensare in qualche curioso modo dal ragazzo, probabilmente non si verrà mai a sapere: alcune composizioni rimbaudiane, sulla cui paternità si nutrono tuttavia dei dubbi, sembrano riferirsi a un rapporto con una imprecisata “madame”, che potrebbe però essere una figura di fantasia. Non esistono documenti ufficiali sul soggiorno milanese di Arthur, né segnalazioni di vagabondaggio che lo riguardassero, o incontri con esponenti del mondo letterario. È attestata solo una sua spedizione dalla Regia Posta Centrale di Via Larga, ma non sembra che in quel periodo abbia richiesto denaro alla famiglia, come aveva fatto in altri frangenti: perlomeno non rimangono documentazioni epistolari di tal sorta.
Franzosini si sofferma sulle testimonianze scritte che alludono ai rari rapporti che Rimbaud ebbe con le donne, in particolare con la Mariam di Harar, che forse lo rese padre. Lo descrive poi fisicamente, nelle grandi mani arrossate e nodose e negli occhi di un azzurro imbarazzante. Accenna agli eccessi comportamentali dettati dal suo carattere violento, arrogante e sfrontato: «insopportabile perché tutto gli era insopportabile». Ciò che risulta davvero fondamentale, al di là della relazione avuta con la misteriosa signora, è che nelle settimane in questione Arthur Rimbaud decise di non scrivere più, di lasciar perdere ogni interesse letterario, arrivando addirittura a cestinare inviti e omaggi da parte di editori ed estimatori: scelta «logica, onesta, necessaria», secondo il parere di Verlaine. Il «silenzio poetico», su cui tanto hanno indagato i critici, pare abbia coinciso con un «silenzio erotico» e con un «silenzio dell’ebbrezza» da alcol e droghe. Una rinuncia e un disconoscimento dell’esistenza fino ad allora vissuta, che già si era espressa in una giovanile dichiarazione di dissociazione da sé stesso («Io è un altro, Je est un autre»), e nel sogno di sconfinamento manifestato nel Bateau ivre, con il rifiuto di far galleggiare la sua folle navicella in una pozzanghera «noire et froide», quale avvertiva fosse allora l’Europa, portandola invece a veleggiare verso altri lidi.
«Il Pickwick», 17 maggio 2018