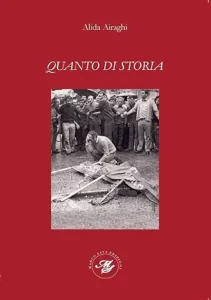Intervista ad Alida Airaghi, finalista al Premio Strega Poesia: “La storia siamo noi, tutti responsabili di qualcosa”
Alice Figini Pubblicato il 08-05-2024
La poetessa Alida Airaghi è finalista al Premio Strega Poesia con la sua ultima silloge Quanto di storia, edita da Marco Saya Edizioni.
Definire Quanto di storia un semplice “libro di poesie” appare quasi riduttivo, perché in queste pagine viene effettuato un catalogo ragionato del nostro tempo, unendo a catena avvenimenti storici e memoria individuale attraverso la luminosità chiarificatrice del verso che isola il sintagma del senso. I versi di Alida Airaghi possono essere definiti una forma di “poesia civile”: nel raccontarci gli episodi della storia contemporanea l’autrice non nasconde indignazione e impotenza, anzi, ce le trasmette con viva emozione e partecipazione, facendoci provare la medesima volontà di riscatto per avvenimenti che, talvolta, sembrano travalicare la capacità di comprensione umana.
La scrittura di Airaghi fissa sottoforma di date alcuni cambiamenti epocali che hanno travolto la nostra società – dalla strage di Piazza della Loggia alla caduta delle Torri Gemelle alla nascita di Facebook, sino alle guerre recenti in Ucraina e a Gaza – e lentamente li dipana attraverso i versi, come nel tentativo di disbrogliare una matassa intricata: dalla data, in un giorno qualunque inserito nel calendario, al senso storico e umano che toglie quel “giorno qualunque” dal suo apparente anonimato. È sempre l’umano a dare un senso alla Storia, forse senza gli uomini non esisterebbe neppure il concetto astratto di tempo né il tentativo di ordinarlo, calendarizzarlo, intrappolarlo in ore e minuti. In Quanto di storia il tempo assume un duplice volto: la memoria collettiva e la memoria individuale, proprio come ne Gli anni di Annie Ernaux, in cui viene narrata la vita di una donna che si incide nel solco di un’intera generazione lungo il filo di una storia condivisa.
“La storia siamo noi, nessuno si senta escluso”, cantava Francesco De Gregori, Alida Airaghi ce lo rammenta attraverso versi che si fanno espressione dello “scandalo che dura da diecimila anni” narrato da Morante.
Ne abbiamo parlato in questa intervista toccando vari temi, dalla guerra alla pandemia, dai social network alla coscienza individuale.
- Ha scelto di dare alle poesie il titolo di date storiche significative, che però forse non tutti i lettori riconoscono nell’immediato. È stata una scelta voluta? Voleva che fosse la poesia a svelare l’evento?
In un primo momento avevo affiancato alla data un titolo che identificasse l’avvenimento con più immediatezza, poi ho pensato che dovesse essere il lettore stesso a recuperare nella memoria la situazione collegata a un preciso, e spesso tragico, momento cronologico.
- La silloge si muove entro i due poli della storia individuale: giovinezza e vecchiaia. La prima poesia si intitola Juvenilia e l’ultima De senectute, in cui si ritrae in due diverse età della vita. Scrive: “si cambia, si invecchia eppure restiamo gli stessi di sempre”. La vecchiaia è un artificio, in fondo si è per sempre giovani?
Sono convinta che ogni età abbia un suo dignitoso profilo, sia esso acerbo o maturo. Gli atteggiamenti giovanilistici degli âgée mi infastidiscono, mi sembrano alquanto patetici.
Personalmente, credo di essere sempre stata più “antica” che giovane, già da bambina e da ragazza. Posata, riflessiva, forse addirittura soporifera…
- Mi ha colpito la scelta di mettere Giovanni Giudici in epigrafe. È una citazione che sottolinea la dimensione privata di quel grande calderone collettivo che è la Storia. Nelle poesie intreccia avvenimenti universali, ad altri più intimi e privati che tuttavia hanno lo stesso impatto di una guerra o di un disastro nucleare su una vita. Secondo lei quale dimensione prevale nella narrazione della storia: quella collettiva, oppure quella individuale? La Storia è un destino che schiaccia e a cui è impossibile opporsi?
Amo la poesia di Giudici, che riusciva a scrivere versi civili e privatissimi con lo stesso candido entusiasmo: parlava d’amore e di impegno sociale sentendosi parte di un tutto. Penso che così dovrebbe essere: siamo frammenti di un insieme, pur mantenendo la nostra individualità, la nostra minima rilevanza personale. E abbiamo comunque voce in capitolo, possiamo e dobbiamo esprimere i nostri sentimenti, le idee, le passioni, senza lasciarci travolgere dalla storia collettiva. Che io non vedo mai come un destino incombente e oppressivo, ma sempre nel suo svolgersi in una prospettiva di sviluppo, di miglioramento, a cui dobbiamo aderire positivamente.
- Elsa Morante definiva la Storia come uno “scandalo che dura da diecimila anni”. Per Morante lo scandalo era il Potere, per lei è lo stesso?
Decisamente non amo il Potere, in nessuna delle sue espressioni: militare, finanziario, politico, religioso, e anche culturale. Credo abbia come obiettivo di manipolare e asservire l’individuo, violentando il diritto di ciascuno all’indipendenza di pensiero e azione. Ma non do invece un giudizio negativo della Storia, che – ripeto – considero come il risultato di una collaborazione umana verso il progresso, pur con tutti i tradimenti, gli stravolgimenti, le crudeltà e le ingiustizie di cui si può macchiare.
- Definisce la morte di Borsellino una “congiura del silenzio” e allude alla sua agenda rossa scomparsa come metafora di una verità per sempre perduta. Questo silenzio, secondo lei, dura tuttora?
Mi sembra evidente che non sia mai stato alzato del tutto il sipario che copre tante stragi di mafia, le collusioni tra politica e alta finanza, i delitti efferati dei diversi terrorismi, le mistificazioni e la corruzione che serpeggiano nei palazzi del Potere.
- Molte poesie sono dedicate alle stragi: dalla strage di Ustica a Chernobyl sino a Via D’Amelio. La poesia narra il dolore delle vittime, di coloro che non possono raccontarlo. La Grande Storia in fondo non è fatta di vincitori, ma di martiri?
Come canta De Gregori, “la storia siamo noi”, vincitori e sconfitti, eroi e disertori, tutti responsabili di qualcosa, nella buona o cattiva sorte. I martiri ci sono e ci saranno sempre, nei conflitti di ogni genere, sul lavoro, nella dedizione a un’idea, nella generosità del sacrificio. Luci nel buio, lampi di verità e coraggio, agnelli che aiutano il mondo a sopportare il male.
- Nel libro tratta anche temi molto privati, tra cui una grave perdita. Inserire il proprio dolore nel solco della grande Storia aiuta, in qualche modo, a curarlo?
La morte di mio marito, nel ’91. La nascita delle nostre bambine, nel ’79 e nell’85. Due grandi gioie e un grande dolore. Felicità e sofferenza si compenetrano, e forse si compensano, continuamente. Il privato che ci coinvolge nel profondo spesso mette in secondo piano la Grande Storia. Che poi però riaffiora, ed è giusto sia così.
- In 11 settembre 2001 si concentra sul crollo delle Torri Gemelle, forse nessuno prima le aveva immaginate come vittime, le aveva piante come vuoto, umanizzandole. Ci si concentra sempre sull’uomo che cade e di rado sulle due Torri. Pensa che le Twin Towers siano la metafora della crisi dell’Occidente?
Senz’altro il crollo delle Torri che sfidavano il cielo, nella loro pretesa onnipotenza, ha colpito l’immaginario universale, evidenziando la fragilità di un’America che si riteneva invincibile. L’orgoglio di Babele frantumato, ridotto in polvere: tutto quel fumo che nascondeva corpi carbonizzati… Come non ripensare al monito “ricordati che sei cenere”?
- Dedica una poesia alla nascita di Facebook: il 4 febbraio 2004. La introduce come “un’idea vincente”, ma poi rivela il rovescio della medaglia. Qual è la sua opinione sui social network?
Non sono iscritta a nessun social, mi sembrano invadenti e schiavizzanti, nella loro presuntuosa e futile aspirazione ad imporsi, esponendo la quotidianità di chi li utilizza. Perché dovrebbe interessare ad altri dove passo le vacanze, che profumo uso, cosa mangio?
- La storia contemporanea si muove tra tre avvenimenti terribili che lei narra in successione: la pandemia di Covid, la guerra in Ucraina e la guerra di Gaza. Racconta sempre le tragedie dal punto di vista dei civili, anche focalizzandosi sugli animali, vittime inermi del conflitto. Riporta gli eventi collettivi a una dimensione privata, individuale, che accresce l’impotenza. Scrive “nel vuoto del cielo che tace di un mondo saziato di pace”, non una preghiera ma una specie di atto d’accusa nei confronti della crudeltà innata degli uomini. L’uomo è per natura malvagio? Secondo lei non c’è nessun Dio?
Non credo in una Provvidenza che predilige un decimo della popolazione mondiale e condanna i restanti nove decimi alla fame, allo sfruttamento, alla mancanza di libertà. Soffrono i civili di Gaza, gli ebrei dei pogrom, la cagnolina della vecchietta ucraina: gli innocenti, gli innocui. Non esiste alcun Dio che possa giustificare quest’enorme ingiustizia. Ma credo nella possibilità di un riscatto finale, a cui dobbiamo contribuire tutti, come esseri umani. Nessuno nasce malvagio, la cattiveria si sviluppa nell’animo di chi si sente poco amato.
- Nella poesia che chiude la silloge scrive “sappiamo di essere storia”. Cosa significa per lei “essere storia”? Qual è il suo rapporto con il trascorrere degli anni?
Pacificato, direi. Non sono ossessionata dal passare del tempo, dalle rughe, dalla morte. La vita inizia e finisce, è giusto lasciare spazio a chi verrà dopo di noi. Mi addolorano le morti precoci, di giovani che non hanno potuto realizzarsi come persone. In giugno compio settantuno anni, mi considero tra i privilegiati che hanno trascorso molto tempo sulla terra.
E non credo nell’immortalità individuale, in una mia esistenza in un qualsiasi opinabile al di là. Si spengono anche le stelle, finirà il sole, si polverizzeranno le galassie, Perché mai Alida dovrebbe vivere in eterno? Se sarò ricordata per alcuni anni da chi ho incontrato e amato, sarà già questo il mio felice paradiso. Tuttavia spero che l’umanità sopravviva in qualche modo, anche solo biologicamente, ridotta magari a un batterio (com’è stato all’inizio!) in cui sia compresa l’intera sua splendida storia millenaria: magari l’intelligenza artificiale ci aiuterà a capire come.
© Riproduzione riservata «SoloLibri», 8 maggio 2024