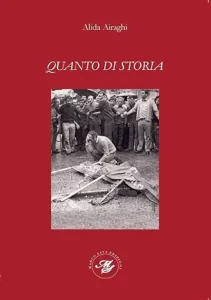MAHMUD DARWISH, NON SCUSARTI PER QUEL CHE HAI FATTO – CROCETTI, MILANO 2024
Con testo arabo a fronte, l’editore Crocetti pubblica Non scusarti per quel che hai fatto, raccolta di versi del poeta palestinese Mahmud Darwish (1941-2008). Darwish, nato in un villaggio dell’alta Galilea, alla costituzione dello stato di Israele dovette rifugiarsi con la famiglia in Libano, tornando successivamente nella sua terra nella condizione di profugo e clandestino. Per il suo attivismo politico fu più volte incarcerato e condannato agli arresti domiciliari, quindi esiliato in vari stati europei e in Egitto, in Libano e a Tunisi. Fece parte del consiglio esecutivo dell’OLP dal 1987 al 1993. Rientrato in Palestina dopo gli accordi di Oslo (1993), visse tra Ramallah, in Cisgiordania, e Amman, in Giordania. I suoi versi, conosciuti e amati in tutto il mondo e tradotti in più di venti lingue, sono stati musicati da alcuni tra i maggiori compositori arabi. Considerato il poeta nazionale della Palestina, alla sua morte, avvenuta a Houston (Texas) dopo un’operazione al cuore, l’Autorità Palestinese proclamò tre giorni di lutto nazionale, e ai funerali di stato, a Ramallah, parteciparono decine di migliaia di persone.
La raccolta da poco edita da Crocetti risale al 2004, e rappresenta una summa dei temi e dei toni di tutta la precedente produzione di Darwish. Nonostante il nome “Palestina” sia citato una sola volta, l’amore per il suo paese viene manifestato costantemente, non solo nell’allusione (più malinconica che indignata) alla sopraffazione politica subita, ma soprattutto nell’accorata nostalgia per le persone e le cose perdute nei lunghi anni di esilio, e nella descrizione dei paesaggi. L’attenzione è rivolta ai colori e ai profumi della vegetazione (ulivi, anemoni, rose, sambuchi), a ciò che si muove nell’aria (uccelli e nuvole, che rievocano immagini impalpabili di sogni, di angeli e cherubini), agli animali sempre simbolo di naturale innocenza (cavalli, colombi, gazzelle, farfalle), agli oggetti che hanno segnato l’attività quotidiana della sua famiglia (“l’eco delle cose parla attraverso la mia bocca”).
Ma anche le città arabe in cui il poeta è arrivato “come un gabbiano” sono presenti con i loro rumori, le musiche e la vivacità dei traffici urbani, le amicizie e gli amori incontrati: Tunisi, Beirut, Baghdad, Damasco, Il Cairo, Gerusalemme: “A Gerusalemme, intendo dentro le antiche mura, / cammino da un tempo all’altro // … Tutta questa luce mi appartiene. / Cammino. Divento più leggero. / Volo e mi trasfiguro”.
Memoria e oblio sono i due poli entro cui ruota la riflessione del poeta: volontà doverosa di ricordare e testimoniare, consapevolezza della caducità del tempo che tutto dissolve. Nella poesia che dà il titolo al libro, il lungo elenco dei ricordi viene riproposto dal soggetto recitante nel presente al mutato “io” che li aveva vissuti nel passato: “Non scusarti per quel che hai fatto, mi dico in segreto. / Al mio altro ‘io’ dico: // eccoli, i tuoi ricordi, tutti visibili: / la noia di mezzogiorno nella sonnolenza di un gatto / la cresta del gallo / la fragranza di salvia / il caffè della madre / la stuoia e i cuscini”.
Persistente è la memoria di altri celebri poeti – come Neruda e Ritsos, l’iracheno al-Sayyāb, il curdo Salīm Barakāt o il siriano Abū Tammām –, ma altrettanto costante è la consapevolezza della fugacità dell’esistenza, dell’impossibilità di rimanere vivi nella storia privata e collettiva del proprio paese: “Tutto quel che hai intorno è dimenticanza”, “Sarai dimenticato, come se non fossi mai stato. / Sarai dimenticato come la morte violenta di un uccello, / come una chiesa abbandonata, / come un amore passeggero / e come una rosa nella notte… sarai dimenticato”. Lo spaesamento individuale, la dissoluzione dell’io, la stanchezza dell’età che avanza (“Ho la saggezza del condannato a morte”, “voglio una morte in giardino / niente di più e niente di meno!”) sono senz’altro fattori di inquietudine personale, ma riflettono anche i timori e le incertezze di un intero popolo. Il sopruso patito dalla Palestina ha per il poeta valenza universale, diventa il male sofferto da ogni vittima a causa della ferocia del potere, in tutti gli ambiti in cui viene esercitato. Nell’ode Al nostro paese (definito “vicino alla parola di Dio, minuscolo come un seme di sesamo, povero come le ali di un gallo cedrone, bottino di guerra”), si avverte la tragica profezia dello sterminio che oggi sta vivendo Gaza: “Il nostro paese, nella sua notte insanguinata, / è un gioiello che brilla per le distanze più lontane / e illumina ciò che è al di fuori di lui… / Quanto a noi, dentro, / soffochiamo ogni giorno di più!”
Nonostante la sofferenza dell’esiliato, del prigioniero, del testimone di una guerra che insanguina e distrugge da decenni la Palestina, Mahmud Darwish pronuncia ancora parole di speranza, ancora incoraggia la sua gente alla resistenza, e si dice fiducioso in un futuro di pace: “Un altro giorno verrà, un giorno femmineo, / alla metafora trasparente, compiuto, / diamantino, di visita nuziale, soleggiato, / fluido, allegro. Nessuno sentirà / alcun bisogno di suicidio o di migrazione… // Nessuna polvere, nessuna siccità, e nessuna sconfitta”.
La sua poesia, così limpida e corale, rivela i caratteri di molte composizioni mediorientali: la descrittività attenta e partecipe, il tono colloquiale, la modulazione musicale percepibile anche attraverso la traduzione grazie alle formule ripetute come in una litania religiosa, la totale assenza di sperimentalismi linguistici, la non equivocabilità del messaggio, che – a differenza della contemporanea poesia occidentale – non lascia spazio a interpretazioni fuorvianti del lettore. La pacatezza formale delle composizioni di Darwish offre uno spiraglio all’utopia di una conciliazione tra le popolazioni di una terra tormentata.
© Riproduzione riservata «Gli Stati Generali», I marzo 2024