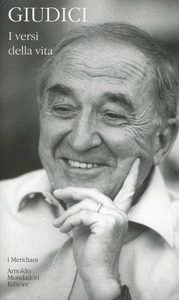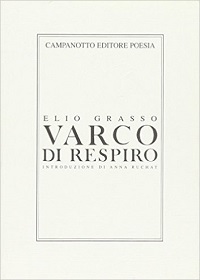MAURA GANCITANO E LA POESIA

Maura Gancitano (Mazara del Vallo, 1985) è una saggista e opinionista italiana attiva soprattutto nell’ambito della divulgazione, con collaborazioni giornalistiche e partecipazioni a dibattiti politici e televisivi. È co-fondatrice di Tlon (insieme al marito, Andrea Colamedici), un progetto di divulgazione culturale e casa editrice; ideatrice della Festa della Filosofia presso le Triennali di Milano e Roma, organizzate in media-partnership con Rai Scuola, e di Prendiamola con Filosofia, maratona streaming di divulgazione culturale nata su sollecitazione del Ministero della Salute; autrice di vari podcast, tra cui Pensare Europeo, in collaborazione con il Parlamento Europeo, e Scuola di Filosofie, raccolta di monografie sulla storia della filosofia del Novecento, prodotto da Audible. Con il saggio Specchio delle mie brame (Einaudi) ha vinto il Premio Rapallo 2022, ex aequo con Bianca Pitzorno.
Ma chi me lo fa fare?, Milano, HarperCollins 2023; Specchio delle mie brame, Milano, Einaudi, 2022; Il gioco del pensiero, Bologna, Zanichelli, 2022; L’alba dei nuovi dèi, Milano, Mondadori, 2021; Prendila con Filosofia, Milano, Harper Collins, 2021; Liberati della Brava Bambina, Milano, Harper Collins, 2019; La società della Performance, Roma, Tlon, 2019; Lezioni di Meraviglia, Roma, Tlon, 2017; Tu non sei Dio. Fenomenologia della spiritualità contemporanea. Roma, Tlon 2016; Malefica. Trasformare la rabbia femminile, Roma, Tlon 2016.
***
Platone nello Ione, nel Fedro, nel Simposio e nel X libro della Repubblica dava un giudizio poco positivo dei poeti, ritenendoli folli posseduti da sentimenti irrazionali, che lo stato dovrebbe esiliare dai suoi confini in quanti produttori di illusioni, credenze false e pericolose. Oggi prevale l’opinione che la poesia non serva a niente, ma – come disse Montale all’assegnazione del Nobel – perlomeno non sia nociva. Condivide questa posizione?
La visione di Platone era calata nel tempo di profonda trasformazione in cui viveva. A quanto ne sappiamo, aveva l’impressione che le storie e l’atmosfera create dai poeti rendessero gli uomini deboli e fossero diventate nocive per il percorso di conoscenza. Platone era in realtà un grandissimo amante della poesia e dell’opera di Omero in particolare, e per questo ha probabilmente scelto di inventare nuovi miti, che contengono alcune tra le immagini più poetiche che l’essere umano abbia mai prodotto. Credo quindi che il suo rapporto con la poesia fosse molto dinamico, come quello con la scrittura. Al di là di questo, ad ogni modo, io credo che la poesia sia essenziale per creare uno spazio di meraviglia nella vita. Forse anche perché viviamo tempi di grande crisi, ma per ragioni speculari a quelle di Platone: oggi la poesia è necessaria per recuperare una certa distanza da una visione del mondo cinica e estremamente materiale.
Secondo Richard Rorty la poesia è creazione del perturbante, “perché il perturbante è il risultato dello sradicamento di una parola dal suo gioco linguistico originario”. Tra i compiti del poeta, quello di porre domande e creare inquietudine è importante quanto quello descrittivo, immaginoso, consolatorio e addirittura ludico?
Sicuramente. C’è una frase di Emily Dickinson che viene spesso usata per esprimere questa sensazione: “Se quando leggo un libro, ho l’impressione che mi si scoperchi il cranio, allora so che quella è poesia. È l’unico modo che io conosca di avvertirne la presenza”. La poesia può avere uno scopo puramente ludico, ma rappresenta comunque un tentativo di manipolare le parole per creare meraviglia, e la meraviglia è sia lo stupore, sia il terrore. È il caso, per esempio, di Wisława Szymborska, autrice di moltissime poesie introspettive e perturbanti, per le quali ha vinto il Nobel nel 1996, ma che insieme al suo amico poeta Stanisław Barańczak componeva dei limerick, delle brevi forme poetiche umoristiche che prendono il nome da Limerick, un paesino irlandese. Che ti faccia ridere, piangere o pensare, la poesia non può comunque lasciarti indifferente.

Heidegger ha studiato e commentato Hölderlin non solo dal punto di vista letterario e filosofico, ma anche con una particolare adesione emotiva. Ci sono altri pensatori che hanno letto i poeti arricchendone i testi non solo a livello ermeneutico, ma anche di percezione sensibile?
È sempre accaduto che la filosofia cercasse di spiegare la poesia, di interpretarla, di costruirle intorno delle categorie. Eppure, credo che l’interesse di chi fa filosofia nei confronti della poesia nasca dallo stato di meditazione a cui la sua lettura può condurti, che quando si scrive di filosofia è fondamentale. In ogni caso, un elenco di filosofi e filosofe appassionati di poesia sarebbe infinito. Basti citare l’amore di Walter Benjamin per Baudelaire, che ebbe una grande influenza sulle sue riflessioni filosofiche, o quello di Maria Zambrano per Federico García Lorca e San Giovanni della Croce, di Julia Kristeva per Stéphane Mallarmé. Un altro esempio di connessione tra poesia e filosofia: nel 1948 Sartre scrisse l’introduzione all’Antologia della nuova poesia nera e malgascia di lingua francese curata dal poeta senegalese Léopold Senghor, e il suo interesse per quella poesia assume un preciso significato politico e di condanna nei confronti del colonialismo.
Che giudizio dà dei filosofi che scrivono versi? Ne ha letti, le sembrano interessanti? Nietzsche, per esempio, gigante del pensiero, aveva scritto liriche mediocri…
Non credo si possa dare un giudizio unitario: esistono filosofi e filosofe che sono capaci di scrivere con più registri e in cui convivono spinte diverse, come nel caso di Sartre, mentre in molti altri casi la scrittura filosofica è il canale principale di espressione, e altri tentativi possono non riuscire o sembrare forzati. Sono modi diversi di usare le parole, e del resto scrivere poesia può essere un’arte che ha senso in sé e si conclude con il suo gesto, non è necessario che sia esteticamente notevole. È anche la ragione per cui molti filosofi e filosofe scrivono poesia, ma decidono di non pubblicarla. Ci sono stati poi alcuni casi, come quello di Edith Stein, in cui la via poetica e mistica ha accompagnato una conversione totale della propria vita.
Legge poesia? Preferisce gli autori classici o quelli contemporanei, gli italiani o gli stranieri? Si è mai cimentata personalmente nella scrittura in versi?
La leggo, anche se in scarsa misura rispetto a saggi e romanzi. Mi piace moltissimo la lingua italiana, quindi amo quella poesia del Novecento (Spaziani, Montale, Luzi, Sanguineti), ma ci sono stati dei momenti in cui ho cercato di avvicinarmi ad altre atmosfere poetiche, come quella americana. I miei preferiti sono forse Mark Strand, Anne Carson e Frank Bidart. Nella lettura della poesia non amo le costruzioni troppo complicate e rarefatte, ho bisogno di figurarmi nella mente quello che il poeta ha immaginato, quindi ci sono anche poesie che non mi sono accessibili, che non riesco ad apprezzare. Quanto a me, ho scritto molte poesie da giovanissima, ma quella di scrivere poesia non è un’urgenza che sento. Mi godo il privilegio di poter essere una pura lettrice.
© Riproduzione riservata «Gli Stati Generali», 25 febbraio 2024