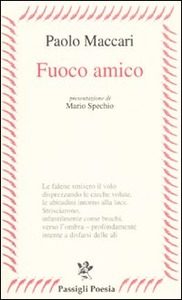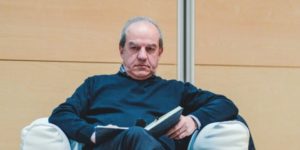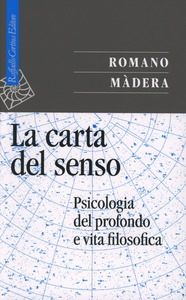ISABELLA LEARDINI, POETESSA E OPERATRICE CULTURALE
Isabella Leardini, nata a Rimini nel 1978, ha vinto nel 2002 per la sezione inediti il Premio Montale. Inclusa in diverse e importanti antologie, ha pubblicato nel 2004 «La coinquilina scalza» per le edizioni «La Vita Felice» di Milano. Ha creato il Festival Parco Poesia, di cui è tuttora direttore artistico, con il lodevole intento di promuovere la diffusione della poesia tra i giovani.
- Qual è stata la tua formazione culturale e secondo quali modalità ti sei avvicinata alla poesia?
Dopo il classico ho studiato lettere all’Università di Bologna. Alla fine degli anni ’90 molti tra i migliori professori dell’ateneo dedicavano proprio alla poesia del ‘900 il loro corso. La mia scelta è stata frequentarli tutti, mi interessavano la critica e la storia della poesia del ‘900 italiano: Alberto Bertoni e Roberto Galaverni in questo sono stati punti di rifermento per me. Nello stesso tempo frequentavo tutte le iniziative e i laboratori del Centro di Poesia Contemporanea, avevo la possibilità di incontrare molti poeti italiani e internazionali. La poesia però era arrivata molto prima, si può dire che sia stata la prima cosa che sono riuscita a leggere e a scrivere.
- Quali sono i tuoi riferimenti letterari e i percorsi di scrittura che più ti hanno influenzato? Quali tra i poeti italiani, più e meno giovani, senti più vicino alla tua sensibilità?
In fatto di letteratura come nella vita sono una di pochi ossessivi amori. Nella mia strana mania poetica infantile c’era Pascoli, nell’adolescenza Pavese. Sereni è stato l’ autore più amato, e nella scrittura del mio primo libro è entrato in cortocircuito con la Achmatova e con Milo De Angelis, che ne è stato l’interlocutore principale. Edna St. Vincent Millay, Elizabeth Barrett Browning, Cristina Campo, Emily Dickinson sono state determinanti per il mio secondo libro, Marianne Moore e anche Antonio Riccardi per quello appena iniziato che sto scrivendo. Tra i coetanei ho notato che trovo molta più affinità con poeti che lavorano anche con la narrativa.
- Puoi raccontare brevemente la tua esperienza di organizzatrice di eventi poetici? In quali difficoltà ti sei imbattuta e quante soddisfazioni hai avuto nella progettazione di Parco poesia?
Ho iniziato ad organizzare a 23 anni con un ideale: portare i maestri e i coetanei che avevo incontrato in un festival che fosse anche un po’ una festa, ma che diventasse un servizio per i giovani che come me scrivevano, un luogo in cui iniziare un percorso serio e sfuggire dall’editoria a pagamento. Credevo di fare qualcosa di innocuo, una specie di gita scolastica, invece ho scoperto presto la vasta gamma delle meschinità letterarie. Le conosco quasi tutte, le so interpretare, dimenticare e ricordare al momento giusto. A me però piace perfino l’aspetto marziale del mondo della poesia, sono un po’ artemidea in questo; e mi appassiona la sociologia della letteratura.
Ballare come una salamandra nel fuoco – mi sono sempre vista un po’ così, perché la mia scrittura per me è in un altrove intoccabile, poesia e organizzazione sono due polarità separate.
Se mi chiedi perciò quali sono le difficoltà te ne dico due: la prima è quando ti accorgi che per te non è una festa ma un lavoro e che anche gli amici si dimenticano di dirti dove vanno a bere, mentre tu sistemi ancora le cose. La seconda è quando non avere i fondi ti toglie la libertà di fare una cosa bella in cui credi e ti costringe a fare una qualcosa che non ti convince: questa è la cosa più dolorosa.
Oggi dopo 13 anni ho realizzato il sogno iniziale; le soddisfazioni sono poche ma profonde: il realizzare un luogo che per i ragazzi ha qualcosa di magico e che getta dei semi, fa nascere cose durature. L’amicizia con cui i poeti che stimo di più si sono messi in gioco accanto a me. E poi anche la consapevolezza di aver creato qualcosa che in qualche modo ha influito sulla poesia contemporanea.
- Perché ritieni che in Italia si legga poco la poesia e come rimediare a questa mancanza?
Perché i poeti credono che il problema non siano i pochi lettori ma i troppi poeti: considerano fastidiosi dilettanti quelli che invece sono i loro potenziali lettori. Tre milioni di potenziali lettori salverebbero il mercato editoriale della poesia se iniziassero a leggerla. Credo che il rimedio sia nel trasformare in lettori di poesia contemporanea coloro che si dilettano a scrivere anche nel modo più amatoriale. Lo si può fare solo incontrandoli, mostrando loro che la poesia contemporanea ha a che fare con quello che scrivono e che leggendola potrebbero perfino scrivere meglio. E farlo con le nuove generazioni è un’esperienza bellissima.
- Ci parli delle tue pubblicazioni e di quello che hai in cantiere, magari concludendo con qualche tuo verso che ti sta particolarmente a cuore?
Il mio primo libro è uscito nel 2004 per la collana Niebo, che in quegli anni Milo De Angelis curava per La Vita Felice. Racconta la giovinezza attraverso un amore non rivelato che ha le sue radici nell’adolescenza. Cercavo di raccontare l’amore non corrisposto come atto conoscitivo nella quotidianità, e volevo farlo con un libro che non temesse il più lirico dei temi, in cui ogni singolo testo fosse autonomo, ma con una struttura narrativa dell’insieme. La coinquilina scalza è stato un libro fortunatissimo, si è creato quasi subito un pubblico anche al di fuori del circuito di chi legge poesia. Era già alla seconda edizione quando nel 2007 una poesia è stata pubblicata sulla rivista femminile più letta in Italia. Dopo pochi giorni quel testo rimbalzava online su blog e forum e tutt’ora non smette di diffondersi da sé su tutti i social network. Le ragazze che hanno amato quella poesia hanno cercato il libro e lo hanno comprato, dimostrando che quando la poesia esce dai suoi confini, incontra anche nuovi lettori capaci di diventare fedeli. Dopo 12 anni dall’uscita il libro è stato ristampato molte volte e le persone non smettono di scrivermi, mi sono arrivate lettere bellissime, in tanti mi hanno raccontato come la mia poesia abbia attraversato le loro vite. Uno di questi lettori è stato il cantautore Vasco Brondi, che ha citato i miei versi in alcune canzoni dell’ultimo album delle Luci della centrale elettrica. Nella prima settimana il disco era già primo in classifica, e così la fortuna della coinquilina sembra continuare a incontrare lettori. Nel frattempo sono uscite diverse poesie in due antologie molto importanti, Les Poètes de la Méditerranée per Gallimard, in cui sono la più giovane dell’intero libro accanto a grandi nomi della poesia internazionale e Nuovi Poeti Italiani 6 di Einaudi. In questi anni ho lavorato al mio secondo libro Una stagione d’aria, che considero il mio più importante: è finito già da un po’ e spero di poterlo presto pubblicare. Nel frattempo, dopo un lungo silenzio, ho iniziato a scrivere anche qualcosa di nuovo, sono solo pochi testi ma già di un altro passo.
© Riproduzione riservata www.sololibri.net/Promuovere-la-poesia-nel-2015.html
1 dicembre 2015