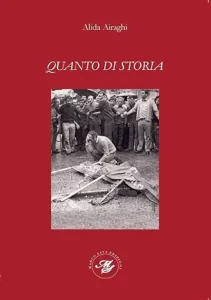For most of us, there is only the unattended
Moment, the moment in and out of time
T. S. Eliot, The Dry Salvages V, 206-207
È qui, presente; o forse sta per nascere.
Segreta ancora, ancora immaginata
solamente. Non certa, non decisa;
potrebbe ripensarci, fuggire,
rinunciare, preferire l’assenza.
O non esistenza, scegli ‒ ti prego ‒
di esserci. Appari come sei:
chiara, evidente.
*
Prova a pesare un pugno di sabbia,
e poi mezzo pugno, così leggero.
Tieni tra le dita solo qualche granello,
e il resto lascialo scorrere, mia mano clessidra.
Non lo fermi, il tempo, e quello che è successo
non puoi fare che non sia accaduto;
ma misura l’istante, la sua sfida
all’eterno. Il solo granello rimasto
fermo tra pelle e unghia:
l’adesso che dura e non si è perduto.
*
Impaziente di essere, diventa vero
e arde e si consuma; improvviso
bagliore, inaspettato pensiero
folgorante (o voce, o battito
di ciglia, o corpo esploso;
corpo in frantumi, incendio).
Abisso dell’ignoto, stella cometa,
lancinante traccia nel buio, nome
appena suggerito:
rivelazione, ascesa, intuito.
Baratro e infinito.
*
L’occupazione dei santi: tendere
(attendere) al punto in cui il tempo
incontra il non tempo, e si perde,
si annulla, conduce all’istante
bloccato nel nero del nulla.
L’aspirazione dei santi: scoprire
nel buio feroce, crudele, severo,
la sua negazione. La luce.
*
Ma quando tutto è immobile,
e non succede niente: l’aria è ferma,
il caldo sopportabile, e un tale silenzio
mi impressiona come fossi morta
senza essermene accorta. Quando nemmeno
il moscerino sull’orlo del piatto si muove,
né l’albero in giardino scuote
le sue foglie. E il cielo è azzurro tutto,
sgombro, terso; il lago liscio,
non c’è bava di vento che lo sfiori.
Allora penso, come una tentazione,
di essere un incidente nel creato,
inessenziale e assurdo; e supplico
un evento qualsiasi, una dimostrazione
della mia esistenza reale.
Ed ecco, accade. Qualcosa accade,
fuori di me e dentro. Un urlo,
un tremito, il merlo che gracchia
tra i rami, e vola via.
*
Affronta l’eterno, vi affonda,
scompare: così inessenziale
e minuto, così puntiforme
e casuale.
Ma in lui, nell’istante,
c’è uno spazio
concreto.
Pensiero, sospiro, offesa, carezza.
Più vero, vivo e reale
di ogni assoluto.
*
Improvviso, l’istante di pace.
Di ordine e tranquillità,
nel sole che scompare al di là
di un muro indefinito di nebbia,
e sospesa la luce non ci offende.
Allora dico no alle parole,
e ripeto no all’istinto
rapace che vorrebbe assorbire
ogni fuori esistente.
Sta buono, mio udito. Mia vista,
abbassati. Lasciate che sia
solo suo, ciò che appare
e attende una resa clemente.
*
Il momento prevale. L’evento.
L’adesso, il qui.
Presente-riassunto del prima, del poi
(degli altri, di noi).
E non te ne andare,
minuto-secondo-istante
del tutto: sii punto.
*
I miliardi di persone che non siamo
– il vecchio cinese curvo sulla ciotola
di riso, la ragazza brasiliana
che cammina sulla spiaggia.
Un bambino londinese, la donnina
messicana al mercato.
Non ci siamo riusciti, a essere
altro, o altri: ma solo la piccola
cosa che viviamo. Qui, e qui;
magari altrove, a volte. Sempre
con le nostre mani, il nostro fiato;
i minimi trionfi del passato,
e un domani previsto e prevedibile.
Gonfi di abitudine,
delusi da tante viltà
che non perdoneremo.
Forse un istante,
uno solo, verrà – in ritardo,
a salvarci.
“Esisto”, diremo,
tagliando un traguardo insperato,
da non condividere.
*
Dall’assenza, da ciò che prima non c’era:
semplicemente, il niente.
Da lì veniamo,
dalla non esistenza. E in essa torniamo,
incoscienti, nemmeno spaventati.
Muti, stupiti del silenzio che ci aspetta,
del moto che rallenta e poi si ferma.
Noi che eravamo presenti
– ad occhi spalancati, a mani tese.
In un istante, assenti.
*
Ci apparirà, come dicono,
tutta la vita che abbiamo
vissuto, e sprecato,
nell’istante finale, oscuro;
nel necessario momento
dell’unico giudizio,
del solo tribunale.
Perché
da soli ci condanneremo
o ci perdoneremo,
quando il futuro intero
svanirà nel passato.
*
Avvicinarsi,
stringere il cerchio.
Puntare dritto al bersaglio,
sforzando la vista.
In prossimità della meta,
del dichiarato impenetrabile:
sia buio respingente
o intollerabile luce.
Verità intravista appena,
il niente che acquieta.
*
Furtivamente arriva,
quasi ladro,
approfittando di un’assenza, di difese.
Gli basta una fessura, e penetra
nel tempo, nel silenzio; tacito irrompe
luminoso, violento. Schiarisce
l’angolo più buio della stanza,
della mente: impone la sua folle
danza in un istante.
Imploso
dentro un colpo di vento,
poi sparisce.
*
Intercettare dio,
il dio della pazienza e del conforto,
il dio che aspetta, e sa, e non ha fretta;
fermo nella potenza,
a sé risorto; visibile
in una chiara, arresa
trasparenza. Così arpionarlo,
con dita scorticate
tremanti, innamorate:
pretesa indifferibile
dopo una vita avara.
*
Qualsiasi momento si ribella;
anche il più insignificante è sovversivo,
dichiara guerra al nulla
e al sempre, è vivo,
arrogante e fiero
della sua unicità:
pronto a sparire,
ma attento a sé,
presente.
L’istante, il vero.
In Nazione Indiana, 2 ottobre 2018, e in Consacrazione dell’istante, AnimaMundi ed., Otranto 2022