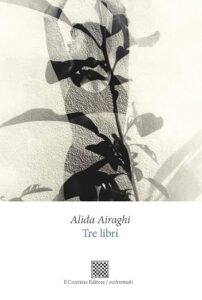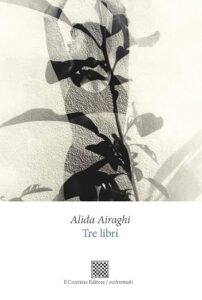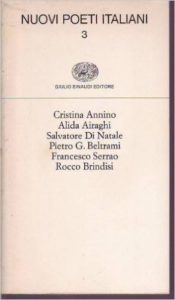È ancora buio quando mi alzo
e spalanco le imposte sul sagrato,
butto ai gatti del cibo, poi scalzo
mi inginocchio a pregare, grato,
«mio Signore e mio Dio», come Tommaso
per un giorno da inventare tutto mio
(sacro per fede o dannato per caso;
rischio e peccato): purché sia io
a decidere, prego, se salvarmi
o bruciare nella colpa; io.
Chiedo davanti al letto di farmi
santo, davanti al muro bianco,
poi veloce mi lavo mi vesto, stanco
già di primo mattino, troppo presto.
Scendo le scale, scaldo il latte
e ripeto ogni pensiero ogni gesto
ogni giorno. La cucina è fredda,
è sola come me, e mi spingo «Vattene
in chiesa che è la tua casa vera».
Ma come buia gelida. Dall’altare
che preparo con candele di cera,
– bianchi teli, acqua, vino, pane –
osservo entrare poche donne, vecchi,
sempre le stesse facce, uno spretato
pentito, con in mano fiori secchi
da infilare in un vaso, impacciato.
Poche frasi dico, all’omelia,
incoraggio a una giornata piena
di buona volontà, che sia
donata all’Altissimo, e serena.
«Mio Signore e mio Dio», chiedo
venia della mia scontentezza,
della paura, del bene che intravedo
e non so perseguire con saldezza.
Poche facce rugose mi osservano:
quanto importi a loro di Cristo,
se quello che predico serva
non riesco a intuire, e non insisto.
A messa finita si intrattengono
nei banchi, raccontandosi fatti
e misfatti del paese, escono
malevoli ma benedetti, compatti
nello scordare il cielo, il sole.
Mi fermo a scambiare due parole
col postino, col vecchio maresciallo,
su chi vive chi muore chi tradisce:
uno cambia mestiere, l’altro giallo
di invidia calunnia e ferisce.
Mi offrono il caffè nel bar centrale.
Sono il notaio, un commercialista,
l’artigiano arricchito, il dentista.
Ridono, parlano, dicono male
delle mogli degli altri, di ragazze
disperate, perdute, forse pazze.
Scommetto che non sanno più baciare,
fare una carezza, dire “amore”.
Scommetto che potrebbero tremare
se solo una gli sfiorasse il cuore
con lo sguardo, ma hanno paura;
cerco con gli occhi un po’ di azzurro fresco
di una sognata, tardiva primavera,
invece è ottobre, nebbia e brina
sui prati, già freddo da galera.
«Mio Signore e mio Dio», dov’è nascosto,
tra le nubi, gli intonaci, nel fango.
Facesse un segno, mi desse una risposta,
a me che corro, spero dispero: piango.
Ma sta zitto anche lui, e tace tutto
e non so cosa fare in queste ore
di mattina, che non c’è un lutto,
confessioni, estreme unzioni, niente.
L’oratorio deserto, anche la sacrestia.
Potrei forse trovare qualcuno all’osteria
del gallo, ma poi dicono che bevo.
Torno a casa, mi sistemo in poltrona
a scegliere brani e letture che devo
proporre alla festa della santa patrona.
Se venisse mia sorella a prepararmi
il pranzo, brontola sempre, sbadiglia
che era meglio per lei assicurarmi
un pasto caldo, un letto in famiglia.
E’ una tortura, ma intanto avrei una donna
intorno, una voce, una presenza:
invece questo vuoto, quest’assenza
a cui penso, che sfioro con mani di sogno
ad occhi aperti, somigliante alla Madonna
della prima cappella a sinistra.
Così l’avrei scelta se avessi potuto,
la mia assente dalla voce di velluto.
Mi scaldo il riso dell’altra sera,
e mangio e bevo con la tivù accesa
dopo un segno di croce fatto in fretta
con lo sguardo incollato allo schermo,
spietato in immagini del mondo
senza dio, o con un dio che è fermo,
lontano dalla vita maledetta.
«Ma muoviti, intervieni, fatti vivo.
Cosa prego altrimenti, come scuso
l’inscusabile male, il male assurdo,
se non c’è una ragione, un motivo…»
Mi addormento sul popolo curdo,
sullo Zaire e le intercettazioni.
Ho le prove delle prime comunioni
alle quattro, alle cinque l’incontro
con il gruppo degli adolescenti
(a guardarli come sono irrequieti, scontenti,
senza idee, senza scogli né slanci,
vien voglia di frustarli, o accarezzarli).
Poi di nuovo una messa, poi la cena
quasi sempre aspettando un invito
che non viene, e sulla schiena
la fatica del giorno finito.
Il rosario per poche vecchine
assonnate, per le altre beghine
così incattivite negli occhi, nei
bisbigli votivi ai defunti e agli dei.
Infine ancora solo, o finalmente;
fuori la notte e dentro, se non fosse
che in fondo al cuore, in fondo alla mente,
in un sospiro, in un colpo di tosse,
c’è quest’ansia del nulla, del tutto,
di farmi testimone di Cristo
per essere quello che voglio, che vuole,
non più quello che fingo. Sono, esisto.
Dieci minuti veri nella cappella
a sinistra, con la madonna, i santi,
il crocefisso, dieci minuti suoi.
Ed è sfiatato, è innamorato
il segno di croce che tento
«mio Signore e mio Dio», per quanto
indegno e umilissimo servo, io.
Io.
In Litania periferica, Lietocolle, Faloppio 1996, in Litania Periferica, Manni, Lecce 2000 e in Tre Libri, Il Convivio 2025.