
NUOVI POETI ITALIANI 6, EINAUDI, TORINO 2012
Recensioni letterarie, testi editi

NUOVI POETI ITALIANI 6, EINAUDI, TORINO 2012
I rami si muovono appena,
‒ docili al vento –
come a ricordare il peso
delle foglie d’estate,
della neve d’inverno:
adesso che nudi
sopportano solo memoria,
a stento speranza di verde.
E la lievissima pena
di uccelli provati dal volo.
**
Camminiamo tra gli alberi,
nel bosco.
Vedi come sono forti, più di noi.
E sicuri di sé, più di noi:
dell’albero vicino e fratello,
di quello amico.
Noi due non ci tocchiamo,
non parliamo.
Scuri e soli.
Tu davanti, io dietro.
E penso che sarebbe bello
vivere come gli alberi, forti.
Noi due distanti, assorti.
**
Scabra la corteccia
alla mia mano, che piano
l’accarezza: mentre lenta
scende la resina,
come colla si rapprende.
Il legno ruvido spurga
la sua linfa, segno di vita.
Attenta a non sporcarmi
le dita, lascio un pegno di me
nel ramo che si spezza.
**
La terra durerà sempre,
e sempre uguale. Non invecchia.
Coperta di foglie e di muschio
respira piano, sonnecchia quasi
come fosse un animale in letargo.
Noi invece cambiamo:
ogni stagione, ogni mattina
siamo diversi.
Mi dai la mano, poi mi respingi.
Ti fingi attento ai miei passi
come insegnassi a una bambina
a non cadere; dopo poco ti allontani.
Così persi tra noi,
così vicini e strani.
Passeggiamo nel bosco,
come due anziani qualsiasi.
Ci sosteniamo
con un leggero fastidio,
rughe sul viso, capelli bianchi.
Di te conosco tutto,
so che ti stanchi.
**
L’elegante betulla è spoglia.
Solo una foglia, esitante, resiste.
Un poco trema, appesa a un nulla;
e aspetta triste il suo ultimo volo.
**
Quanti anni avrà il pino
più alto del bosco?
Così saldo piantato nella terra,
senz’altro più vecchio di noi,
e più sicuro dei suoi domani.
Bianco di neve, in pace
col suo destino.
Tu appoggiato al suo tronco duro
rimani chino, riprendi fiato:
in guerra col tuo corpo stanco
mentre lui greve tace.
**
L’aria buona
ci riempie i polmoni,
ci sfiora le guance;
fredda penetra nei nostri giacconi
e sugli alberi
smuove le frasche.
Dalle tasche tiriamo fuori
due arance.
Mangiamo agrumi, aria,
assenza di rumori.
**
Nel loro silenzio è
il nostro cammino: indifferenti
al respiro opaco
che ci esce dalle labbra.
Zitte sentinelle del bosco,
non si scuotono al tonfo leggero
delle pigne cadenti,
ritte torri vegetali. Padroni
del cielo e della terra, i pini
assaporano un mite trionfo.
**
Il cielo non è consolante,
minaccia la pioggia, la neve.
Un velo di nebbia si tende
tra i rami dei pini, ci bagna
la faccia: ti rende distante
mentre avanzi piano
e io ti seguo, come si deve.
**
In questo silenzio interrotto
solo da qualche sfrigolio di frasche,
dal sordo cadere di pigne,
o dallo stormire dei rami
dell’imponente noce davanti a noi,
ascolto di sotto in su il tuo rado parlare,
la tua voce che mi sprona.
Le fa eco lontano il pigolio di un tordo.
E io vado, cammino, ti raggiungo:
così buona da baciarti la mano
senza dire niente.
**
Percorriamo un sentiero da altri
tante volte battuto. Raramente è piano,
sgombro di rovi, o sassi, o buche.
Camminiamo verso un traguardo lontano,
a passi brevi, lentamente.
Nuovi nello sguardo perso sul bosco.
E poi arriviamo, lievi,
con un pensiero taciuto.
In Il silenzio e le voci, Nomos, Busto Arsizio 2011
Lo chiamavano Pedro – ma non era spagnolo –
per il baffo spiovente, la voce suadente, l’aspetto
gitano e marino, un destino di sole e di acqua
nel sangue, imbastito di scarne parole.
Da vent’anni viveva nel faro, che era sua moglie
e sua mamma perché ci passava le estati e i natali;
da solo. Ogni mese arrivava la barca a motore
a portargli coperte vestiti vivande: lui scendeva
le scale a spirale, caricava sei sacchi di roba
sulle spalle – farina per il pane, il vino, saponi.
E poi rimaneva in silenzio a mangiare,
assorto a pensare. Sull’isola gli scogli, sentieri
dirupati, brughiera di mirto e rosmarino.
Usciva di mattino, fischiava a un pescatore,
a un contadino che lavorava l’orto,
ma senza dire niente. Inutile parlare,
faticoso: non c’era abituato.
Piuttosto cantava, canzoni d’amore
che aveva imparato in gioventù.
Adesso che è maturo, quasi vecchio,
Pedro guardiano fa compagnia a se stesso
e non gli serve altro, non ha più voglie
rimpianti speranze. Le poche stanze
del faro sono reggia e monastero:
la minima cucina e il forno a legna,
la camera da letto, il cesso e un salottino.
Di giorno tutto bianco di luce,
di notte le stelle splendenti che quasi le tocchi.
Antares, Cassiopea come un diadema,
sapersi nulla scrutando l’orizzonte,
strizzando gli occhi a rincorrere i lampi
che dalla lanterna sorvolano il mare,
indagano il cielo. Ma c’è da fare,
sempre. Spazzare i pavimenti,
controllare le lenti e la pompa
dell’acqua, comunicare i dati
alla centrale, riempire i secchi
nella cisterna fuori, per lavarsi
e per bere. Eppure, sono cielo
e mare, la linea di confine che li segna
a occupargli la mente, i sogni
quando dorme: a fissare dall’alto
quella riga sottile gli viene da pensare
che la terra sia piatta, e non rotonda:
lunga, distesa, un deserto infinito
e paziente. Azzurro, blu cobalto,
giallo al tramonto, rosato all’alba,
di notte nero in quello spazio aperto
solcato a volte da una fila di navi,
più spesso vuoto e muto. Pedro
si perde, cerca l’aiuto di capodogli
e delfini, oppure un roteare di falchi,
gli stridi dei gabbiani per non sentirsi
abbandonato e solo,
che se morisse nessuno lo saprebbe.
Gli piace udire almeno la risacca,
uno sciacquio remoto prima di addormentarsi;
o quando legge il farfallio di mosche,
di falene, le rondini che sbattono
sui vetri, e il vento, il vento forte;
la burrasca, una buriana di scirocco
o grecale, qualsiasi cosa che lo faccia
star bene o male, ma vivo e vero. Da sveglio
col binocolo sugli occhi
non sa cosa si aspetta di scorgere lontano,
nel sulfureo bagliore di flutti giganteschi:
le ossa spolpate di un antico fenicio,
larvale spettro implorante vendetta
che un tempo era bello, era alto
e amava nella stiva ragazzi moreschi;
finì negli abissi del buio avvinghiato
a una trave (ah, temi, marinaio del mondo,
la morte per acqua!). O spera, il guardiano del faro,
di essere il primo a vedere in un’alba nebbiosa,
confuso col vento, lo sbuffo di vapore
alzarsi dal dorso della bianca balena
trafitta di fiocine, indomita, furiosa,
vittoriosa. E dietro di lei un vascello fantasma
che sfiora le onde, si alza, sprofonda,
poi vola su ali poderose tra le nuvole,
scompare come un sogno, è una fiaba
narrata davanti al camino da un vecchio
che accarezza a parole lui bambino.
Lui bambino non ancora Pedrito
pesava i suoi giorni sulla riva
ciottolosa, a lanciare sassetti
rimbalzanti sull’acqua, poi nudo
si tuffava a bracciate innervosite
dove non si toccava: e il faro
era lontano, a guardarlo, futuro
del futuro, promessa
di silenzio e di avventura, di freddo
e di paura; il faro del destino
di Pedrito bambino.
Che cresciuto e forte come un toro,
con le braccia abbronzate e il primo pelo
sulle guance sul petto tornito
ci portava le signore più grandi
straniere, imparava l’amore, le stringeva
sdraiato tra le chiglie delle barche
a riposo, e la luce del faro
sciabolava i capelli normanni vaporosi,
lo invitava ad osare ogni notte di più.
Così pensa i suoi ricordi compagnia
mentre è solo appoggiato con la testa
alla parete brufolosa inumidita
della stanza in cui conta le ore
di fronte alla finestra salmastra,
fumando sigarette stropicciate
tra le dita, e dalla radiolina
ascolta la voce distante
che racconta una partita indifferente.
In Lo Straniero n.180, giugno 2015 e in L’attesa, Marco Saya edizioni, Milano 2018
I
Rumori lontani nel bosco,
fruscio di foglie a terra
e rami calpestati.
Intorno nebbia, mentre tenace
il sole non si arrende.
Noi spaesati a cercarci,
ruvide labbra, parole stente.
Il canto di un fagiano
ci sorprende, stride,
nel quasi giorno dell’addio.
Non ti conosco più,
in questa guerra che ci divide,
nostro presente
senza pace, senza domani.
II
Mi tremano le mani
se penso alle stentate primavere
passate; finiti i soldi,
anche l’amore faticava.
Ma non ti rassegnavi:
“domani sarà meglio, domani
andremo fuori
a comprare scarpe libri vestiti;
tutta nuova ti voglio vedere,
regalarti dei fiori”.
Attrice comprensiva
rispondevo facendoti coraggio:
maggio giugno l’estate
indolente che arriva.
Passa un giorno, poi un anno.
Non cambiava mai niente.
III
Allontanarci e ritrovarci,
questo mi proponevi,
prudente e saggio
con paura di sprecarti
in troppo dare. Non mi prendevi
nemmeno per mano, vergognoso
degli sguardi della gente:
mentre io avrei voluto sollevarti
aldilà di colline, di boschi
e confini: spaziare immensi
azzurri, col coraggio
dei folli e dei bambini.
IV
Consolante il ricordo di noi
mi si affaccia,
se nello specchio ritrovo
il profilo imparato a memoria,
sul letto la traccia
del corpo abbracciato,
dal soffitto oscillante un filo
di ragno
avvolge nel velo la storia
che è stata la nostra.
Nostra stanza,
mio tempio ora zitto:
mio cielo mio scoglio
e deserto.
Non voglio non volo,
ancora non provo.
V
Mi alzo mi vesto esco.
Vago come un automa,
impietrita in qualsiasi
parola, o gesto.
Poi improvvisa una voce,
poi tante, musica forte da un posto
che ignoro (balera
caffè ristorante): mi chiamano
dentro, scombinata compagnia,
“sei sola?”.
Rido tra loro, angeli sconosciuti,
canto, bevo. E via dal coma,
dannata tristezza;
salvezza decisa in una sera.
Il Pickwick, 13 settembre 2020; Gli Stati Generali, 5 marzo 2023
In Rime e varianti per i miei musicanti, Marco Saya Edizioni, Milano 2020
I
Conosci il vuoto,
ore lente a passare
e l’insonnia la notte.
Speravo di incontrare
qualcuno, uscendo,
ascoltare parole.
Grazie prego grazie:
almeno.
Invece silenzio,
ombre, sguardi altrove.
Forse solo per questo
ho deciso.
Non avevo niente da fare,
niente da perdere.
Più nessun desiderio speciale.
Mi sono innamorata
per questo motivo
solamente. L’amore
c’entra poco, o niente.
II
È bastato un tuo ritardo,
la scorsa settimana,
per farmi tremare.
Così, improvvisamente,
ho capito, con paura di capire.
Poi una frase,
buttata lì come un saluto
del tutto indifferente,
e uno sguardo
quasi fosse una carezza.
Ho capito, e nel capire
mi sono fatta tenerezza.
III
Non mi hanno insegnato
(quando mi hanno insegnato
a parlare) a dire di te
le cose giuste (a chi di te
voleva sapere), che giusto
ti facessero apparire.
Non mi hanno insegnato
parole diverse
per fare diverse le sere
le mattine. Nostre.
Sono rimaste
di tutti e di sempre,
le mie parole.
Come le storie
e gli amori di tutti.
IV
Probabilmente non lo sai
o non vuoi confidarlo
nemmeno a te stesso.
Hai bisogno di me.
Sempre, e adesso.
Per questo sono qui, stasera:
pena di noi, oppure
un cuore troppo tenero.
Timore che perdendomi
tu finisca per perderti.
Eccomi, allora,
e non è stato facile.
Scalare una montagna
per chiederti «Lo vuoi,
il mio bene, ancora?»
V
Proprio non mi hai capito,
forse mai.
Sei lì che aspetti sempre.
Fermo, zitto. Non so
se insofferente.
Aspetti che sia io a parlare,
a fare il primo gesto.
Murato nel silenzio,
incementato.
Mi costa tanto
riuscire a non abbatterti
a colpi di bazooka.
Se non mi chiami adesso:
ti detesto.
VI
Tenaci a sperare
per pura abitudine,
senza scopo o ragione.
Domani uguale a ieri
(così sfocato
che non lo ricordiamo,
il nostro passato di nebbia);
un giorno, un altro giorno,
il giorno prima.
Un’ora, o l’ora dopo,
il nuovo anno.
Continuiamo,
solitudine in due;
ma non vale la pena.
VII
Io sì.
Non quell’altra
che alla fine ti sei scelto.
La poverina, la noiosina.
Io sì.
Non lei ubbidiente.
Dolce, silente.
La cagnolina, la cinguettina.
Io sì.
Non una brava in cucina.
La cucitrice, la stiratrice.
Donna in cornice.
Io sì.
Lei che sbadiglia,
che ti somiglia.
La sorellina, la cuginetta.
Io sì.
Ti ho consegnato,
con lei,
la mia vendetta.
VIII
Stanca distratta distrutta
non ho nemmeno voglia di parlare.
Mi fa fatica anche solo guardarti.
Vedrai che piano piano tornerò
quella che ero.
Non essere però troppo paziente;
non sei mio padre, non sono una bambina.
Vedrai che se mi sgridi
qualche volta, (mio severo)
ce la farò a cambiare.
Non ti deluderò
per sempre.
IX
Ti verrò in mente quando
mi avrai perduto.
Improvvise torneranno
a stupirti
le frasi che suggerivo,
incantate, sospese.
«Noi siamo il cielo»,
dicevo. «Siamo gli alberi».
Ricorderai
di come sorridevo,
di come sorridevi «Anche le nuvole?»,
chiedendo.
«Anche», mentivo.
X
E lontano in due dimensioni
ti ho nascosto nelle nove
restanti.
Sparso ovunque. Sperso
come sempre sei stato.
Ma riaffiori, ogni tanto,
imprevedibile inatteso,
a guardarmi
con la tua timidezza
di offeso, benché innamorato.
Lontano irraggiungibile,
tempo e spazio nemici.
«Il Pickwick», 12 gennaio 2020
In Rime e varianti per i miei musicanti, Marco Saya Edizioni, Milano 2020
I
Mille cose. Troppe cose
assediano i felici,
senza lasciare loro il tempo
di accorgersi che sono
così felici.
E non lo sono, infatti:
confusi, forse; distratti.
Desiderosi d’altro.
Invece io ti ho avuto.
Ho avuto te,
e mi ricordo di questa sola cosa.
Di questa cosa sola
mi accontento.
II
Non può morire nemmeno
quando muore,
una qualsiasi storia d’amore.
La nostra, poi.
Me la coltivo come un germoglio:
la curo la sorveglio,
nella tiepida
serra
del ricordo.
Mia tenera allegria, se resto sola.
Orgoglio
che taccio in compagnia.
III
Eri con me.
Eri con me d’estate.
Probabilmente luglio, inizio agosto,
e insomma era l’estate
di una non vacanza.
La stanza, chiara; la terrazza.
Il letto, il copriletto a fiori.
Il caldo fuori, non dentro
quella stanza.
Era d’estate, l’autunno
non ci preoccupava.
Un posto senza mare,
senza dopo,
bastava.
IV
“Finirà − hai detto piano −
Come tutto finisce”.
Sembravi angosciato
dal tuo fiato, addirittura.
Perché non crederci
perché non riprovare
− riflettevo guardandoti.
Forse hai paura.
Te lo leggo negli occhi
che hai paura.
V
Non hai voluto finire.
Io ti incalzavo, ti incoraggiavo.
“Dimmi!”, dicevo.
Implorando: “Spiegami!”
Pronta a chiedere scusa,
a umiliarmi, a promettere
per l’eternità.
“Se le cose stanno così…”,
ti muravi, alzando le spalle.
Spacciando bugie
(le tue!) per verità.
VI
Giorni grigi più grigi
del cielo, con le nuvole basse
che promettono gelo
e neve. Mi regali
una vita impossibile,
se scompari nel nulla
(se resti e sei nulla).
Chi ci guarda dai vetri
ci vede infreddoliti,
tremanti nell’inverno
non solo per la neve.
VII
Non ci sarò.
E non per cattiveria.
Semplicemente, sarò lontana,
tra gente e strade
che non conosci.
Via, via, lontana da qui.
Non per vendetta.
Adesso lo capisci, finalmente?
Te lo devo ridire? Lo ripeto:
con calma, con pazienza, senza fretta.
Non ci sarò.
Adesso sì, che sono seria.
VIII
Ne ho persi, di giorni:
e sono tanti.
Il fiore della giovinezza,
direbbero gli amici
benpensanti.
È che si paga tutto
stando insieme:
il bene e il male
fatto e ricevuto.
Non tiriamo le somme
da meschini: dato/avuto,
molto/poco.
Siamo stati generosi tra noi
− perlomeno in tenerezza.
Poi, ci siamo tenuti compagnia.
IX
È inverno, nell’aria,
o cos’altro? Bambini silenziosi
spaventati, per strada.
Amici seri, quasi in lutto.
E io, anch’io: aspetto zitta
impaurita che uno
da lontano torni, mi porti
un fiore − gentile nel freddo −
a scaldarmi mani, occhi,
il cuore distrutto.
X
Cosa resta di te? Non saprei.
La tua assenza, di certo.
Un vuoto di gesti
un rosario di sguardi mancati.
Silenzi, silenzi.
Pesanti, ricattanti fantasmi
sulle scale.
Ma è passato tanto tempo.
Il tuo non dire
il tuo non essere,
non mi fa male.
Il Pickwick, 28 luglio 2019
In Rime e varianti per i miei musicanti, Marco Saya edizioni, Milano 2020
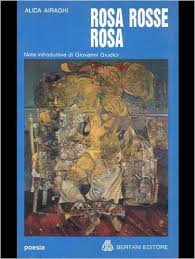
ROSA ROSSE ROSA, BERTANI, VERONA 1986