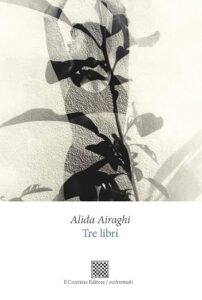I piedi neri che sporgono dal letto,
brache arrotolate sui polpacci: Isaac dormicchia
in canottiera, sudato, sporco di terra, e il fiato
gli puzza d’aglio e di vino. Il suo vicino è Moses,
curiosi nomi di ricchi ebrei, i loro, che invece
più musulmani di così si muore.
Moses fa il bucato in una bacinella, lava
calzini e varia biancheria; mai fatto prima
in vita sua il bucato, ma ora che è via di casa
si arrangia in tutto, e canta nenie, Moses, e lava
spazza cucina, proprio come se fosse una donna.
Appeso al muro è uno zaino semivuoto, due giacche
a vento buttate sulla sedia per quando piove,
per terra sandali, scarpe da tennis quasi nuove.
Isaac insiste a non aprire gli occhi e pensa
a sua sorella, a una ragazza bella che ha incontrato
la mattina e lo guardava triste, imbarazzata
al ciao di lui, al suo sorriso: ma sua sorella mai
starebbe ad osservare uno straniero; e Isaac sa
cos’è bene e cosa male, lui che è nero.
Moses lo spruzza di acqua saponata, gli urla «Alzati!»
facendolo grugnire. Isaac si alza, spalanca fauci
e braccia, va a pisciare nel cesso lordo da far paura
e poi si veste senza lavarsi, si cambia i pantaloni,
infila una camicia scura.
Decidono di uscire. La camera odora di corpi
lucidi accaldati, ci sarebbe bisogno d’aria fresca,
di una sera pulita nei polmoni.
Ciondoloni si avviano per la strada sterrata
fino a un viale che sbuca sul raccordo anulare;
parlano ridono, fanno versacci ogni volta che ne incrociano
una, poi le girano attorno caroselli eccitati,
carambole di balli improvvisati, e lei si arrabbia,
li manda a quel paese.
Moses e Isaac riprendono il cammino,
sulla strada una fila di auto interminabile,
voglie pesanti da sabato sera, noia di tutti contro la loro
gioia: grazie dell’aria, della libera uscita, di una vita
lontana dalla storia.
Memoria di non esserci, di non essere contati
altrove, in un dove che non sia la propria stanza,
danza che trova un senso solo nel movimento,
nella fatica di andare sempre. Ecco che vanno
in centro, prendono l’autobus, stipati tra tanti
disperati come loro, lingue diverse, altri colori,
e fuori dai finestrini è buio, e nei pensieri buio
o luce a sprazzi. Ragazzi pronti alla discoteca
si trascinano a cercare nuove facce e nuovi sessi,
storditi amplessi per dimenticarsi. Isaac invece vorrebbe
ritrovarsi, sentirsi pieno e accolto e benedetto;
in un letto di piume magari, in un fiume che scorre,
dentro una donna moglie. Asseconda le sue voglie serali,
si avvicina a due giovani amiche, spingendosi tra loro
con il suo corpo forte; ad una preme il seno col torace,
all’altra tocca il fianco come senza volerlo. Moses
lo guarda e ride, Isaac strabuzza gli occhi, gode
del suo coraggio malandrino, finché un giovanotto
lì vicino avanza minaccioso a dirgli di piantarla:
ma Isaac lo sovrasta di una testa, è una bestia di muscoli
e allegria, l’altro non osa nulla e torna via,
a sedersi al suo posto. In centro tutti scendono,
le due donne ancheggiano gazzelle e ammiccanti
davanti ai due ghepardi noncuranti. Belle le luci
come se fosse giorno; intorno gente, tanta ed elegante,
ressa nei bar, voci e baci, bulli e pupe.
Isaac e Moses camminano veloci, guardano rapaci
e avidi quello che non avranno: una cena con bianche
tovaglie, camerieri ubbidienti alle spalle, madame
ingioiellate, e soldi, soldi. Trovano conoscenti
ad angoli di strade affollate, magrebini, ganesi,
altre facce già viste nei loro quotidiani appostamenti:
è un fioccare di saluti rituali, di frasi gutturali
incomprensibili, grandi manate, abbracci,
esibizioni candide e orgogliose di oggetti in vendita
invenduti, oltraggi e sputi dietro a chi passa ignaro
e non acquista, canti di scherno ad un inverno
dei cuori, a un fuori meno freddo di ogni interno.
Moses e Isaac svoltano in un vicolo diverso
da quello dell’altra settimana: questo si chiama
Via della Borsa. Tentano l’avventura e la ventura,
che il loro Dio gliela mandi buona come la volta scorsa
almeno, una matrona spaventata che non aveva opposto
resistenza. Senza fiatare seguono uno dal fare impiegatizio,
tenera pelatina e occhiali spessi, un giubbino di stoffa
striminzito. Di colpo lo spintonano in un canto, Moses
gli blocca mani e bocca, il tizio quasi casca mentre
Isaac gli strappa il portafoglio dalla tasca, e via
di corsa che non rinvenga, che non gli venga in mente
di urlare. Si fa presto a contare quarantacinquemilalire,
bestemmia Moses in italiano, Isaac ha il fiatone
e guarda lontano, vorrebbe riprovare con un altro
tra la folla, ma -strano- è Moses questa volta a non volere,
dice «Ci bastano per bere, per fare qualche cosa»,
e maledice la sorte, implora la morte più schifosa sui ricchi
nascosti a farsi ricchi senza che nessuno li tocchi.
Loro, pitocchi, devono adesso
tornarsene a casa, rabbiosi impotenti, riprendere l’autobus
con poca gente e stanca, stare zitti a guardarsi le scarpe,
appoggiando la testa al finestrino. Che voglia di altre notti,
altri vestiti addosso, padri severi a cui ubbidire, parole
compagnia consolazione, e invece qui il silenzio perdizione,
condanna a non esistere.
Alla fermata giusta Isaac e Moses scendono, ed è già scuro,
le macchine più rade, il viale non risponde ai loro passi.
Moses fischietta, Isaac dà calci ai sassi.
Ritrovano le donne accanto ai fuochi, e quella, sfatta,
che avevano schernito poco prima. Fanno salamelecchi,
sorrisini: le chiedono se con quanto hanno rubato
li può accontentare tutti e due,
veloce, e buona almeno lei, sul prato.
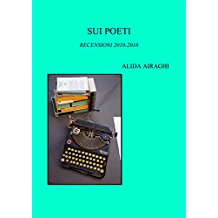 e-book, 2017
e-book, 2017