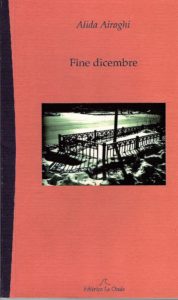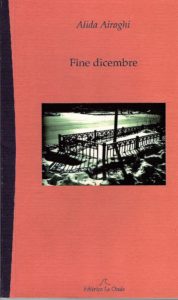La suora aspettava. Seduta, dietro la cattedra, con le mani incrociate intorno al rosario, con gli occhi bassi: pregava. Ogni tanto alzava lo sguardo da topo, in fretta, passandolo sulle nostre teste, a controllare che nessuna parlasse, o si distraesse. Aveva imposto: silenzio!, sollevando in aria il mento e il braccio a indicare qualcosa che doveva scendere dal soffitto (benché non ci fossero buchi o aperture di sorta) o entrare dalle finestre, nonostante fossero chiuse.
Era un pomeriggio tranquillo, dopo la ricreazione in cortile eravamo risalite in aula tutte sudate, scalmanate. E nel brusio lei, la suora, aveva dato quell’annuncio tremendo. «Gesù ha qualcosa da dire a ognuna di noi. Ad alcune parla sempre, ad altre ha parlato in occasioni speciali, ad altre ancora parlerà, quando meno se lo aspettano». E aveva preso a ruotare gli occhi sulle nostre facce, a esplorarci i pensieri. Io avevo abbassato sguardo e idee, spenta ogni riflessione: temevo che le parole di lei fossero preludio a una sofferenza che già oscuramente presentivo.
«Quando meno se lo aspettano»: doveva essere il mio caso. Escludevo la possibilità che Gesù mi avesse parlato, in passato, senza che io me ne fossi accorta. Sapevo che avrebbe dovuto farlo, per esempio, dopo la Prima Comunione: me l’avevano assicurato a dottrina. Ma nessuna voce dall’alto si era fatta sentire, e nessun bisbiglio dall’interno del cuore. Se dei pensieri mi erano venuti, in un’occasione così mistica, m’avevano spaventato per la loro irriverenza. Del tutto profani, del tipo «Uffa, questa Messa non finisce mai…», oppure «Chissà come sono venuta in fotografia?». Non me li aveva certo mandati Gesù.
«Chiamiamolo, Gesù, che scenda tra noi, e ci parli. A ciascuna deve dire qualcosa. Chiamiamolo, preghiamo». Ci fece alzare e recitare preghiere che con Cristo c’entravano poco, anche un Eterno Riposo e un’Avemaria. La Clotilde Borghese, la più tremenda e irrispettosa, glielo fece notare, alla suora. Che per chiamare Gesù bisognava pregare solo Gesù, e non i suoi parenti. Ma lei aveva scosso le spalle, si era stretta nello scialle nero, e alzando l’indice «Eccolo, eccolo, è già tra noi – aveva detto – Sedetevi, chinate la testa, pregate. Si avvicinerà al vostro banco e vi parlerà. Fate silenzio. Concentratevi».
Mi erano venuti i brividi, mentre cercavo di osservare se fosse cambiato qualcosa intorno a me, tra le compagne, in classe. Possibile che una tale presenza non si facesse in qualche modo notare?
Il silenzio era quasi assoluto, tutte sembravano impressionate. Quasi tutte. Vidi le spalle della Clotilde sussultare in un riso nervoso, il suo ciuffo muoversi tra le mani in cui aveva nascosto la faccia. Veniva da ridere anche alla Giannina, sua compagna di banco. Mentre un’altra si allacciava la scarpa.
«Gesù verrà vicino a chi di voi saprà e vorrà ascoltarlo. Solo a chi sarà puro di cuore. Se ridete, se pensate ad altro, lui se ne accorgerà. E vi punirà con il suo silenzio. Quando sarete sicure di aver sentito la voce di Gesù, quando le sue parole vi saranno entrate nell’anima, verrete alla cattedra, e mi racconterete cosa vi ha detto».
Ebbi la precisa sensazione che da quel momento sarebbe iniziato per me un supplizio destinato a durare chissà fino a quando; che quella specie di ago che mi sentivo pungere dentro ogni volta che mi consideravo in colpa, avrebbe ripreso, da adesso, a farmi male. Mi misi seduta con le mani giunte. Guardai un attimo la mia compagna di banco, bellissima come sempre, e in posa come sempre: con gli occhi rivolti al cielo, le labbra che bisbigliavano, le dita intrecciate con forza. La Clotilde e la Giannina continuavano a ridere, a scoppi, come se stessero per soffocare. Cercai di raccogliermi nelle mie riflessioni, chiusi gli occhi.
«Gesù parlami. Per favore, questa volta almeno, parlami. Dimmi qualcosa, oggi è più importante di sempre. Dimmi quello che vuoi, sgridami. Ma fatti sentire. Devo riferirlo alla maestra». Pregavo con un’ansia che a Gesù, se fosse stato davvero lì, avrebbe dovuto far pena. In che modo chiamare Gesù? Come farsi ascoltare? Anzi no, stavo sbagliando: non ero io a dover parlare, era lui. Non era lui che doveva ascoltare, ero io. Quindi non dovevo pregare, dovevo tacere. Tacere. Tacere anche con i pensieri, che non mi portassero lontano, come al solito. Non pensare a niente. Come fossi morta. A niente. Provai. Come si fa a non pensare? Anche pensare di non pensare è già un pensiero. Cercai di immaginarmi davanti agli occhi uno spazio bianco, tutto bianco. Il niente. O la neve. Che però si porta dietro troppe cose. Via, scacciare dalla testa la neve. NIENTE. Come un cartellone vuoto parato dentro il cervello, pensare a niente.
Dal suo banco si alzò la Graziella, avvicinandosi alla cattedra, alla suora stupita che le chiedeva «Ti ha già detto qualcosa?» E lei faceva cenno di sì e le sussurrava nell’orecchio. La Graziella era tra le più brave della classe, aveva i quaderni più ordinati, con tanti bei disegnini: era come il suo nome, aggraziata, anche nel camminare, tanto che faceva dondolare il grembiule; anche nella voce, che trascinava gentile in cantilena. Sfido che Gesù l’aveva scelta per prima, e chissà cosa le aveva detto di bello, perché la suora, adesso, sorrideva.
Cominciò una quieta processione di bambine che, con regolarità, senza affannarsi, andavano a riferire alla suora il loro messaggio personale. Io ero rimasta al mio posto, immobile, sempre con le mani giunte. Ma ero in buona compagnia. Tentai di rituffarmi nella concentrazione di prima: forse la cosa migliore era cercare di immaginarsi Gesù, con la sua faccia, la sua veste, le sue labbra: ecco! Soprattutto le sue labbra. Pensarle intensamente finché si fossero dischiuse, avessero articolato qualche parola. Ma, per prima cosa, quale Gesù? Gesù bambino o Gesù in croce? La questione sollevava enormi differenze.
Mi distrasse di nuovo lo scattare in piedi, improvviso, della mia compagna di banco. «Anche lei!» pensai, mentre si dirigeva devotamente alla cattedra. Eravamo rimaste un gruppetto di cinque o sei, ci controllavamo l’un l’altra, esitanti: io già sul punto di piangere, terrorizzata al pensiero di rimanere l’unica inchiodata al suo posto, segnata a dito. Si alzarono altre due compagne. Una era la Giannina che aveva smesso di ridere. Mancava la Clotilde, e questo mi consolava: Gesù non poteva scegliere lei prima di me, io ero più buona, da sempre, la preferita della maestra. Perché non doveva parlarmi? Per cosa punirmi?
In verità aveva detto, la suora, «solo ai puri di cuore». Ero pura? Io sapevo benissimo quali e quanti pensieri – inconfessabili e tuttavia da confessare, pena l’inferno – venivano a tormentarmi in continuazione, sapevo bene con quale rammaricata indulgenza cedevo a loro. Mi chiusi il viso tra le mani, cercando di nascondere e rinfrescare insieme la pelle che scottava. Si alzò anche la Terracciolo, proprio la Terracciolo, ripetente, che in quarta faceva ancora fatica a leggere. L’ansia mi si era trasformata in panico, non vedevo più niente, mi sentivo tutti gli occhi della classe addosso e continuavo a premermi le mani sulla faccia.
«Adesso. Vieni adesso. Ti supplico. Salvami».
Si avvicinarono alla cattedra le due che erano rimaste, la Clotilde per ultima, sempre ridacchiando. La suora mi chiamò con molta dolcezza. «Vieni, vieni anche tu. Sei la sola a non avermi detto che cosa Gesù ti ha comunicato. Vieni».
Perché non capiva, lei così vecchia, lei maestra, perché non capiva che non avevo niente da riferire? Voleva che le raccontassi una bugia? Mi avvicinai e mi afferrò per un braccio, premendomi contro il suo corpo, facendomi abbassare la bocca sulla sua cuffia. «Dimmi – diceva – Dimmi…» Le dissi, come voleva. «Niente» mi umiliai. E tornai al posto, disperata.
La vidi, un po’ contrariata, peggio, forse addolorata, aprire la finestra, invitarci a scendere in giardino. Non ricambiò il mio sguardo. Scesi, con le altre, e con un mattone sul cuore. Passandomi vicino la Clotilde accennò di nuovo a una risatina, ma io la bloccai furiosa «Buffona, pagliaccia!», urlandole contro. Alzò le spalle, facendomi cenno col dito che ero matta. Non ce l’avevo con lei, ma con chi l’aveva preferita a me, dopo tutto quel ridere. E con la suora che mi aveva costretto a rivelarle quello spaventoso nulla, quel vuoto di comunicazione cui ero stata, io sola, condannata. Andai a sedermi su una panchina, all’ombra, mentre le altre si disperdevano tutt’intorno, leggere, esaltate nel loro stato di grazia…
Mi chinai e, con un gesto che ripetevo ormai da mesi, mi infilai tre sassolini in ogni scarpa. Non avevo patito abbastanza, se ancora non ero riuscita a diventare “pura di cuore”. Mossi i piedi in modo che almeno un sassetto finisse sotto le dita, dove faceva più male. In tal modo mi punivo, da tempo, con tanta ferocia mortificavo la carne e con tanto fanatismo esaltavo lo spirito, che mia madre spaventata aveva consultato il nostro vecchio pediatra, ricevendone risposte rassicuranti: «Cambierà, cambierà…» Ma la suora, durante un colloquio coi genitori, aveva preso i miei in disparte, mettendoli al corrente commossa del suo presentimento che rasentava ormai la certezza: io mi sarei donata a Dio, avrei offerto la mia esistenza alla Chiesa. Mia mamma mi aveva guardato con tale apprensione, riferendomi le supposizioni della maestra, che mi ero sentita in dovere di smentirle, di sbeffeggiarle addirittura. Da allora, tuttavia, mi vedevo spiata, controllata, sia a casa sia a scuola: e facevo attenzione a non comportarmi diversamente dalle sorelle, dalle compagne.
Per accontentare tutti, stavo imparando a essere una bambina infelice.
Mi si avvicinò la Clotilde, aggredendomi con la solita sfrontatezza: «Sei rimasta male perché Gesù non ti ha parlato?» Come faceva, mi chiedevo, a essere tanto indelicata, a non capire che mi feriva? «Chi ti dice che non mi abbia parlato?» «Io credo che non abbia detto proprio un bel niente a nessuno». «Cosa dici? Tutta la classe ha ripetuto alla maestra le parole di Gesù». «Si saranno inventate tutte una frase, come ho fatto io. Sai cosa ho detto? Che Gesù era contento di me, e mi raccomandava di continuare così».
A una tale mostruosità, balzai in piedi spaventata: «È un sacrilegio!» Vedevo aprirsi davanti alla Clotilde l’abisso infernale, alzarsi le fiamme che lambiscono gli spergiuri e gli infedeli. Lei rideva del mio stupore, del mio terrore. «Anche la Giannina si è inventata la risposta. Me l’ha confessato poco fa». «Stai dicendo un’eresia! Gesù ha parlato. Magari solo alle pure di cuore. Però ha parlato. Io lo so». «Come vuoi. Sei tu sola a crederci. L’unica a non esserti inventata la frase, e l’unica a credere a tutto quello che dice la suora: come una bambina di prima elementare. Credi sempre alla suora perché vuoi farti suora». Questa rudezza mi colpì come una sberla, ma mi ripresi e tentai di ributtarle addosso il suo sarcasmo: «Mi fai ridere. Mi fai proprio ridere». Non ridevo, invece. Ero costernata. Mi sentivo truffata dal mondo intero. «Non voglio più parlare con te. Io, suora!» Feci qualche passo per allontanarmi. I sassi mi facevano male. Dovevo far finta di niente: continuai a camminare dritta come un fuso. Che la Clotilde non capisse, non mi smascherasse ancora più crudelmente.
Accennai qualche saltello. Soffrivo. Appena al di là della siepe mi chinai a svuotare le scarpe.
(1984)
In Appuntamento con una mosca, Stamperia dell’Arancio, San Benedetto del Tronto 1991, e in Inverni e primavere (e-book), 2016