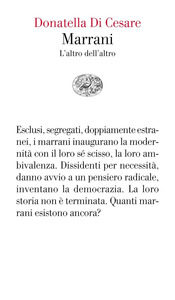Tra le sue ultime pubblicazioni: Gadamer, Il Mulino, Bologna 2007; Se Auschwitz è nulla. Contro il negazionismo, Il melangolo, Genova 2012; Israele. Terra, ritorno, anarchia, Bollati Boringhieri, Torino 2014; Heidegger e gli ebrei. I «Quaderni neri», Bollati Boringhieri, Torino 2014; Tortura, Bollati Boringhieri, Torino, 2016; Terrore e modernità, Einaudi, Torino, 2017.
In breve, ci può descrivere il suo percorso umano e di studi, in ambito familiare e scientifico?
Ho sempre letto molto, fin dall’infanzia. Non giocavo molto volentieri, ero introversa e perciò preferivo rifugiarmi nella lettura che non mi deludeva mai. Ricordo ancora quel forte senso di estraneità verso il mondo da cui fui sopraffatta, un pomeriggio d’estate, mentre mi aggiravo nel piccolo orto che circondava la casa dei miei nonni. Avrò avuto sette anni. Per il resto il mio percorso fu scandito da vere e proprie battaglie per leggere un po’ di più, di giorno e di notte. Ho ancora davanti agli occhi l’immagine di mia madre che mi strappa di mano un libro dicendo «basta». Non ho avuto la solidarietà da parte delle donne della famiglia fra le quali mi sentivo un outsider. Ero invece molto legata a mio nonno materno che nel 1925, per la sua militanza politica, aveva dovuto emigrare negli Stati Uniti, a New York. Aveva fatto ritorno dopo alcuni anni, mantenendo una visione aperta e un profondo interesse per le sorti del mondo. Cominciai a imparare il tedesco da sola a tredici anni, perché pensavo che mi sarebbe stato utile per i miei studi. Frequentavo il primo liceo quando mi accinsi a leggere il Manifesto di Marx e Engels, seduta su una vecchia sedia sempre in quello stesso orto. Mio nonno si affacciava ogni tanto – fiero e orgoglioso. Per via di complicate vicissitudini familiari, di cambiamenti inaspettati e repentini, il mio percorso di studi è stato irto di difficoltà. Ma in compenso ho avuto maestri straordinari – a cominciare da Gianni Rodari in quinta elementare. Come non menzionare, poi, Hans-Georg Gadamer?
Quale tra i filosofi del Novecento ha lasciato tracce più profonde nella sua sensibilità e nella formazione del suo pensiero filosofico?
La filosofia di Martin Heidegger mi ha influenzato profondamente. Nel 1979 lasciai l’Italia. Mi ero appena laureata e avevo vinto una borsa di studio del governo tedesco. Ebbi così la possibilità di studiare per quattro anni all’Università di Tubinga, una cittadina molto raccolta, nel cuore della Svevia. In quel tempo leggevo molto le opere dei filosofi greci, soprattutto Platone, e i versi dei poeti tedeschi. Friedrich Hölderlin era un compagno di solitudine.
Fu in quel periodo che mi immersi nello studio di Heidegger, a partire proprio dalla sua riflessione sul poetare. Per il resto la mia formazione è stata molto tedesca. Ma durante il mio secondo, lungo soggiorno in Germania, a Heidelberg, ho lavorato anche alla Hochschule für jüdische Studien (Scuola Superiore di Studi ebraici), oltre che ovviamente, all’Istituto di Filosofia. Decisive sono diventate le pagine di Walter Benjamin da cui, anche ora, non potrei separarmi.
Nel suo interesse rivolto “all’altro dell’altro” ha inciso maggiormente l’esperienza personale (incontri, memorie, educazione, viaggi) o il coinvolgimento intellettuale (letture, reazioni accademiche, approfondimenti teologici)?
Non sono mai riuscita a distinguere quel che è personale e quel che è intellettuale. Forse perché la filosofia è per me inestricabilmente connessa con la vita, anzi è la mia vita. Propendendo per l’assoluto, ho sempre avuto molte difficoltà di relazione con gli altri. Proprio per questo, però, ho dovuto riconoscere che senza gli altri non sarei nulla. Mi è sempre piaciuto quel modo in cui Emmanuel Lévinas spiega che io mi costituisco nell’istante stesso in cui volto verso l’altro per rispondere alla sua domanda, in quella torsione. Pur percependo spesso la mia alterità, persino – come dicevo – la mia estraneità, non mi sono mai sentita di far parte pienamente di una comunità. L’appartenenza è stata sempre anche una non-appartenenza – un po’ dentro, un po’ fuori. Perciò la figura del marrano, l’altro dell’altro, l’altro anche rispetto all’ebreo, mi ha sempre affascinato. Per molti versi il destino dei marrani mi è sembrato il mio ed è questo il motivo per cui ho deciso di scrivere un libro su questo argomento, spesso tabuizzato, dopo aver meditato e studiato a lungo negli ultimi anni.
Crede sia veritiera e temibile la recrudescenza dell’antisemitismo, in Italia e in Europa? Ritiene sia un fenomeno da ricollegarsi più genericamente al razzismo oppure pensa sia nutrito di/da ideologie più radicali?
Non parlerei di «recrudescenza». Termini come questi sono a mio avviso fuorvianti, perché inducono a credere che l’antisemitismo sia un fenomeno del passato, un capitolo semichiuso della storia. Basterebbe allora attendere il lavoro del progresso per chiuderlo definitivamente. Non è così. Abbiamo già visto che la storia non segue la marcia trionfale del progresso e che Auschwitz è stato pensato e realizzato da una civiltà raffinata come quella tedesca. Inoltre l’antisemitismo prende forme diverse. Certo non può essere ridotto solo al razzismo. Alla base dell’antisemitismo vi è quell’antico odio antiebraico che ha accompagnato per secoli il cristianesimo. Solo negli ultimi decenni, dopo la Shoah, una profonda autocritica ha cominciato a mettere in dubbio la teologia della sostituzione.
A livello popolare e culturale, è più temibile il negazionismo o l’indifferenza? Come combattere entrambi, nella scuola, nelle università e attraverso i media?
Ritengo che sia molto più pericoloso il negazionismo. L’indifferenza è l’atteggiamento di chi, cinico e disincantato, si volta dall’altra parte. Noncuranza, insensibilità, ipocrisia, disinteresse sono i mali della società contemporanea basata sull’egocentrismo spietato. Prima vengo io, poi gli altri – prima noi, poi loro. Ben diverso, perché più violento è il fenomeno del negazionismo, cioè di chi nega che la Shoah abbia avuto luogo, che siano esistiti i forni e le camere a gas. Anche di fronte alla prova più schiacciante i negatori continuano a negare. Li ho chiamati «dobermann», perché sono chini crudamente sull’osso che non smettono di rodere. Si attaccano a un piccolo particolare, al brandello di una prova che alla fine non muterebbe l’entità del crimine. Loro scopo non è la ricerca, ma semplicemente la negazione. Ho mostrato che il dibattito storico è votato al naufragio. È infatti impossibile trovare argomenti per confutare il negazionista che si trincera nel luogo della sua negazione. Ma c’è di più. Chi discute con il negazionista sul piano dell’indagine storica, se per un verso ottiene solo una negazione, per l’altro accetta l’impostura.
L’opinione dei negazionisti è la “verità” di Hitler. Non deve sfuggire la complicità tra l’annientamento e la negazione, tra i nazisti di ieri e gli odierni assassini della memoria, cioè gli hitleriani della seconda e terza generazione. La risposta deve essere insieme culturale e politica.Qualche anno fa, contro il parere di molti, anche all’interno delle comunità ebraiche, ho auspicato l’introduzione di una legge, già esistente in quasi tutti gli altri paesi europei, che riconoscesse il negazionismo come crimine. Ne ho seguito poi l’iter fin quando, l’anno scorso, è stata approvata. Posso dire di aver ottenuto, fuori dal parlamento, due leggi: il reato di negazionismo e il reato di tortura.
© Riproduzione riservata SoloLibri.net https://www.sololibri.net/Intervista-a-Donatella-Di-Cesare.html 14 maggio 2018