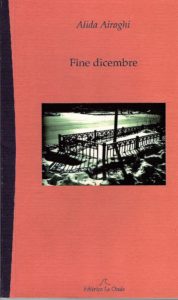Mio figlio cammina davanti a me, spalle spioventi, riccioli lunghi sul bavero del giaccone da pastore. Se accelero il passo e mi metto al suo fianco certo riesco a vedergli il cerchietto d’oro infilato all’orecchio sinistro, che quando mia madre l’ha scoperto si è portata la mano sugli occhi, senza dire niente. Ma io ho capito cosa pensava. Si può odiare un figlio? Dicono di no, e io Nicola non lo odio: non mi piace, vorrei che non fosse così. Speravo che il figlio mio fosse un’altra cosa, no questo ragazzo che si fa chiamare Niki, e si firma come Lauda, e parla più svizzero che italiano: perché non vuole, perché non lo sa.
Nicola cammina dondolandosi, con le mani in tasca, senza voglia. Non gli piace il paese, non gli piace il Natale, e neanche venire a Messa. Neanch’io ci vado, a Messa, neppure stanotte che è Natale; ma li accompagno fino alla chiesa per far felice mia moglie. Li accompagno fino in piazza, loro tre, e li aspetto fuori a godermi questa notte freddissima di Lama, a guardarmi la Maiella incappucciata: proprio come facevo da ragazzo, quando sognavo la fidanzata e il lavoro e di andarmene per il mondo. Nicola, piuttosto di starsene fuori con me, se ne entra con la madre e la sorella: ha paura di dovermi parlare, o che io gli faccia i miei soliti discorsi. Mi chiedo com’ero io, a diciassette anni, e concludo: diverso. Leggevo tanto, invece a mio figlio chi gliel’ha mai visto un libro in mano? Non sapevo ballare, e lui sa fare solo quello: con movimenti da epilettico, immagino, ma non potrei giurarlo perché non sono mai stato in discoteca con lui. Io credevo nel comunismo. Qui a Lama, duemila abitanti, avevamo aperto una sezioncina, e andavamo in giro col distintivo sulla giacca. Duro, poi, abituarsi alla Svizzera degli anni ’60, da comunista. Ci credo ancora. Siamo rimasti in pochi. Nicola non crede a niente. Mi guarda ironico, se commento alla mia maniera il giornale. Non lo dice, ma mi prende per scemo. Pensa sia un illuso, un ingenuo.
Lama è cambiata, in venticinque anni. Hanno costruito le scuole, anche le medie, hanno ripavimentato le strade, fatto parcheggi perché ormai ci sono quasi più macchine che persone. Molti di quelli che erano venuti via con me sono ritornati a vivere qua per sempre. Io non me la sento, ho paura di sbagliare: per me, che sono ancora giovane, ma soprattutto per loro, per i ragazzi.
Si avvicina uno col montone, la moglie in pellicciotto. «Benedetto!» mi urla. Grandi pacche sulle spalle, le due signore si baciano. Nicola alza gli occhi al cielo. Non lo riconosco, ma faccio finta di sì, aspettando che quello che dice mi aiuti a riscostruire la sua storia. «Hai messo su pancia!» fa. Anche lui, penso, ma chissà, forse l’ha sempre avuta. Le donne si prendono a braccetto, chiacchierano veloci. Lui si mette a raccontare della sua Alfa 164 che ha lasciato in garage per paura che gliela graffiassero, vuole sapere che auto ho io. «Siamo venuti in treno» gli rispondo, e lo vedo piccato. Dice che si è ristabilito a Lama da quattro anni, che ha aperto una fabbrica di oggetti in peltro, e che gli affari gli vanno benino: ma si vede che bluffa, guadagnerà tre volte quello che prendo io come capocantiere a Lucerna. I miei ragazzi camminano davanti a tutti, io glieli mostro, da dietro, lui mi dice che purtroppo non hanno figli, ma due nipoti maschi che lavorano con lui gli danno grandi soddisfazioni. Comincio a intuire chi può essere, da giovane lo chiamavamo Carlino, non aveva finito la naia per un’ernia, e poi era vissuto in Germania per vent’anni.
Siamo quasi arrivati alla chiesa. L’hanno ridipinta di quel colorino rosa che va tanto di moda adesso, e che io non posso sopportare. Dentro una chiesa non ci metto piede da quando mi sono sposato. Diciotto anni. C’è un sacco di gente, mancano dieci minuti a mezzanotte.
Vedo mio fratello più giovane, che fa l’animatore in parrocchia: non ci siamo mai capiti. Mi fa un cenno con la mano. «Auguri, auguri». «Auguri, auguri». Mi sento lontano da tutti, diverso da tutti. Mia moglie, eccitata come se andasse al veglione, mi stringe il braccio. «Dai, Benedetto, vieni anche tu». Io scuoto la testa, ci vorrebbe proprio questa, mi viene sulle labbra una parolaccia che trattengo a fatica. Carlino o come si chiama sorride incredulo: «Ancora la stessa idea? Caro mio, guardati intorno!» «Intorno?» penso, per vedere facce pasciute come la sua, mio figlio che accenna un sorrisino beffardo, mia moglie che starnazza: «No, no, è cambiato: adesso è diventato pidiessino…». Brutta oca che non capisce niente; non hai mai capito niente di partiti e deve dire la sua su tutto. La ragazzina mi guarda, un po’ spaventata un po’ solidale, la mia Tania: ha tredici anni ed è la più in gamba della famiglia.
Piano piano entrano tutti, sempre belando come pecore, commentandosi a vicenda, sparlando di chi gli sta di dietro, da bravi cristiani. Io mi siedo sui gradini, fuori dalla chiesa. Un poco discosto da me, due vecchi si raccontano le loro storie, guardandomi ogni tanto, come volessero coinvolgermi nei loro discorsi. Hanno addosso i mantelli neri che si usavano trent’anni fa, il cappello calato sugli occhi. Da dentro si sentono le note dell’organo, suonato sempre dalla signorina, ormai settantenne, che mi faceva lezione di catechismo quando ero piccolo. Sono canzoni che ricordo ancora. Mira il tuo popolo, Salve Regina, Noi vogliam Dio. Fumo una sigaretta e me le ripasso, così com’erano scritte sul libriccino madreperlato di mia sorella, e sorrido quando mi ritorna in mente quell’espressione riferita alla madonna, ‘avvocata nostra’, che mi riempiva di ammirazione e stupore per le abilità legali di Maria, mai sospettate.
Il cielo di Abruzzo è sempre lo stesso, anche a dicembre, anche di notte. Mi sembra così diverso da quello di Lucerna, sarà che là non lo guardo mai: chi si mette a contare le stelle, in Svizzera? Invece qui è vicino, sembra che se alzi un braccio puoi immergere la mano nel blu-nero, e ritirarla felice e scottata come se avesse toccato il paradiso. “O falce di luna calante” … Una volta sapevo il mio D’Annunzio a memoria, adesso mi ricordo pochi versi: “Senza mutamento è l’aria”, o quello che mi sono ripetuto tante volte, quando non riuscivo ad addormentarmi per la nostalgia, ma mi commuove ancora: “Ah perché non son io co’ miei pastori?”
Eccomi qui, coi pastori che non ci sono più, con la Maiella che incombe, e due vecchi che mi osservano. Uno di loro mi si avvicina: «Freddo, eh?», ma non aspetta risposta. «Siete comunisti?» gli domando, e loro si guardano, un po’ spaventati, in silenzio. «Perché non entrate in chiesa?» proseguo. «E te perché non entri?» mi ribatte il più spiritoso dei due. Ridacchio, mi stringo nel cappotto. «Sono comunista» rispondo; che strano, come se fosse una sfida, con orgoglio e presunzione. «Non credo in Dio» continuo, pronto a fargli una lezione, di filosofia e di politica insieme. «Dio…- alza il dito ad ammonirmi il più timido – Dio è in ogni luogo. In cielo, in terra e in ogni luogo. Anche nei comunisti». «E poi una cosa è Dio, una cosa Gesù Bambino che nasce stanotte» rincara l’altro. Scuoto le spalle, penso di essermi imbattuto in due veterani di Comunione e Liberazione. Schiaccio la sigaretta sotto la scarpa. «Anche noi abbiamo le nostre canzoni». Fischietto “L’Internazionale”. Loro non mi degnano più di uno sguardo. Passo alle note di “Fischia il vento”, che fa sempre presa, è corale e buona come la loro “Ostia divina”. Mi viene in mente una delle ultime sfilate per il Primo Maggio, in Svizzera. Ormai non ci vado più, sono diventate patetiche. Ma dieci anni fa era ancora rischioso, e tutti insieme lì, coi compagni, a sventolare bandiere, ad applaudire, ti sentivi tessera di un mosaico, strumento essenziale di lotta. Tu e i compagni e il partito e la rivoluzione. Eravamo comunisti. Adesso siamo pidiessini. Ci schedavano. Adesso vengono a patti, ci danno anche ragione. Forse abbiamo vinto.
Dalla chiesa non arriva più musica, né voci. Sarà il momento della predica o della comunione. Loro sono stati più abili di noi nell’inventarsi dei segni, dei simboli. Noi, in fondo, oltre al pugno chiuso, alla falce e martello che non esiste più, alla bandiera rossa che è stata ammainata, non abbiamo altro. Loro hanno la croce, la confessione che li libera da ogni peccato e tutte le volte che vogliono ritornano puri, intatti. Hanno la comunione con Dio, possono diventare Dio. Chi li vince, a questo punto?
Mi fumo, con la nuova sigaretta, lo sconforto, la delusione di me ragazzo e uomo che ha sperato e creduto nel sol dell’avvenir: ed ecco che improvvisamente gli dicono «Compagno, non era vero niente, abbiamo scherzato…». Mi alzo a sgranchirmi le gambe. I vecchi hanno ripreso a parlottare, poi si avviano verso il portone di legno della chiesa. Vorranno prendere la benedizione finale. Li guardo, curvi sotto i loro cappelli, più vicini degli altri alla terra che presto raggiungeranno. Hanno bisogno di credere nella resurrezione dei corpi, io invece so che rimarrò polvere in eterno, e chi si è visto si è visto. Mi avvicino al presepio che hanno messo lì in una nicchia esterna della chiesa.
Da bambino mi piaceva il bue per le grosse pieghe che ha sul collo: sembrava tanto annoiato di dover stare seduto quindici giorni in mostra, a masticarsi una manciata insipida di fieno. E poi, tra il popolo accorso a fare festa, amavo il pastore con l’agnellino sulle spalle e il cappello verde sulle ventitré, e la contadinella con le trecce e col bastone che custodisce le oche. Pensavo fossero fidanzati, e ogni giorno li avvicinavo un po’ di più, e a Natale li mettevo proprio appiccicati, piedistallo contro piedistallo. Ci sono anche in questo presepio sotto la Maiella. Mi passo la mano sugli occhi, sto diventando vecchio.
Si schiude il portone di legno, cominciano a uscire alla spicciolata, e con la gente escono le note dell’organo, le voci stridule delle donne: “Tu scendi dalle stelle”. Sono convinti di essere diventati più buoni.
Me, non mi avranno mai.
(1990)
In Fine dicembre, Le Onde, Chianciano Terme 2010 e in Inverni e primavere (e-book), 2016