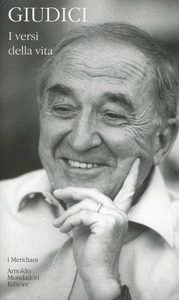GIOVANNI GIUDICI, POETA
- Ritieni che si possa fare un discorso di classe all’interno del fenomeno poetico? In altre parole, credi che la poesia sia un’espressione culturale borghese?
Se parto dalla mia esperienza, devo constatare come nell’ambiente in cui sono cresciuto l’occuparsi di poesia (e in generale di cultura) venisse immediatamente considerato un tradimento, un privilegio rispetto alle esigenze materiali, di mantenimento, che assorbivano chi mi circondava. C’era quindi un rifiuto popolare istintivo verso l’arte ritenuta il prodotto dello sfruttamento che la classe dominante esercita su quella dominata. Ma io credo che tutta l’arte, e quindi anche la poesia, non siano espressioni particolari di una classe, svolgano semmai una funzione vicaria, di sostituzione di qualcosa che non si ha e magari non si potrà mai avere. In termini cristiani, sono convinto che se non ci fosse stato il peccato originale, non ci sarebbe stato bisogno dell’arte; cioè in una società utopisticamente perfetta non ci sarebbe bisogno di scrivere poesie, e l’arte avrebbe un senso solo come divertimento, passatempo. Invece, allo stato attuale dello sviluppo borghese, è assurdo parlare di morte dell’arte proprio perché essa svolge più che mai adesso la sua specifica funzione.
- Sì, ma la società non è tutta borghese, e in concreto si dovrebbe un po’ riesaminare il rapporto poesia-classi subalterne.
Lukacs insegna che la poesia se è veramente tale si riscatta dalle sue origini ideologiche e dai suoi condizionamenti economici e culturali. Io penso che il più corretto atteggiamento di classe nei confronti dell’arte non sia il suo rifiuto come valore borghese, bensì lo sforzo e la lotta riappropriativa da parte delle classi dominate. Chiaro che la riappropriazione fondamentale è quella politica ed economica, ma parallela a questa conquista deve essere quella culturale e espressiva.
- Intanto però di continua a delegare la scrittura a chi rappresenta anche culturalmente la borghesia.
Credo che sia confortante che molti giovani, molte donne scrivano, e non per condizionamenti quali l’ambizione, il voler pubblicare, il successo. Tutte cose molto borghesi. Ma per parlare di sé, per divertimento o per protesta, per reclamare un riconoscimento.
- Qual è il tuo giudizio sulla poesia “sociale” o di protesta?
Non ci credo molto, forse perché penso che tutta la poesia sia sociale e di protesta, nel senso che esprime insoddisfazioni e contraddizioni che non sono contingenti, che non si eliminano in nessun sistema politico. Il comunismo non potrà ovviare, per esempio, all’infelicità in amore. Come ho già detto, in me c’è questa radice cristiana per cui sento che l’uomo deve scontare un peccato originale, e la civiltà risulta dagli sforzi per ridurre le conseguenze di questo peccato. Il comunismo in questo senso dovrebbe essere il gradino più alto raggiunto nel processo di civilizzazione. Per tornare alla poesia, personalmente la considero e la pratico come un’ambizione romantica di sopravvivenza. Ma essa rimane sociale come attività, come produzione di certi risultati. E’ quindi un esercizio, e come tale insegnabile, magari già dalle scuole elementari. Penso però che si debba assolutamente scoraggiare la mitologia di una poesia intenzionalmente sociale, perché se si bada ai soli contenuti si ottiene una normatività burocratica nel cui ambito c’è spazio per qualsiasi cialtrone. Ne è un esempio la storia letteraria dell’ URSS dopo il 1930.
- C’è anche una poesia che non è sociale nelle intenzioni, ma vive e si nutre di una situazione drammatica o alienante. Cioè senza fingersi sociale, lo è veramente.
Sì, più che una poesia, il fatto stesso che si scrivano poesie, non importa se belle o brutte; come nel caso di certa poesia operaia, o più genericamente di lavoro, prodotta in condizioni ambientali agli antipodi delle condizioni culturali che hanno accompagnato, nei ceti colti, il farsi della tradizione poetica e letteraria in genere. E’ un dato che depone a favore della necessità della poesia come fatto compensativo, e ribadisce in modo profondo, anche in termini “spirituali”, la radicale (in senso marxiano) carenza e necessità di umanità. Siamo in presenza di un’umanità, la nostra, decapitata.
- La poesia, quindi, come uno dei tanti bisogni di cui si parla?
Poesia come sintomo del bisogno di umanità totale, che in quanto tale non sarà mai colmato.
- Il QdL ha aperto un dibattito su questi temi. Se si riuscisse a metter in piedi una pagina letteraria a scadenze fisse, o meglio ancora, una pagina creativa sulla quale i compagni potessero pubblicare le loro poesie, le loro fantasie, con quali criteri pensi sarebbe giusto organizzare questa pagina?
Certo non con criteri estetico-letterari di tipo tradizionale, ma con motivazioni in linea con la destinazione e la concezione del giornale. Si dovrebbero scegliere poesie di testimonianza, di informazione, pur tenendo ferma la distinzione tra lingua poetica e linguaggio comunicativo. E senza dimenticare che tra una poesia vera e la poesia-slogan o la poesia-bollettino, che nel contesto del QdL hanno un loro senso preciso, corre la stessa differenza che c’è tra un ritratto di Velasquez e una fotografia. Chiaro dunque che se arriva una poesia di Carla Fracci dedicata alla Scala, quella la si lascia pubblicare al Corriere della Sera: a ciascuno il suo, a ciascuno la “testimonianza” che merita.
«Quotidiano dei Lavoratori», 29 gennaio 1978